 Sandro Carotta, Alla ricerca della bellezza. Percorsi monastici, Nerbini 2023 («Orizzonti monastici»; 48). Il famoso e prolifico benedettino di Praglia ha raccolto in questo volumetto della rinata serie degli «Orizzonti monastici» scritti e contributi di varia dimensione e occasione, «indirizzati a tanti uomini e donne che, sempre più numerosi, cercano nei monasteri un punto di riferimento per la loro vita cristiana» – e non solo, verrebbe da dire. I titoli dei testi dicono già molto: La vita monastica come desiderio, Elogio dell’inutile, Deserto e solitudine, Formazione al silenzio, e così via. Non si cercheranno particolari approfondimenti in queste pagine, si troveranno bensì molti spunti, molti nomi (un po’ troppi, forse) e molte citazioni; e qualche interessante riflessione sull’accompagnamento spirituale: «L’eccessiva preoccupazione di sé non è indice di un cammino interiore ma può essere la manifestazione penosa e non riconosciuta del proprio narcisismo. Il direttore spirituale deve portare la persona guidata a specchiarsi in Cristo e non nel torbido dell’ego». Non sono d’accordo, ma questo non c’entra.
Sandro Carotta, Alla ricerca della bellezza. Percorsi monastici, Nerbini 2023 («Orizzonti monastici»; 48). Il famoso e prolifico benedettino di Praglia ha raccolto in questo volumetto della rinata serie degli «Orizzonti monastici» scritti e contributi di varia dimensione e occasione, «indirizzati a tanti uomini e donne che, sempre più numerosi, cercano nei monasteri un punto di riferimento per la loro vita cristiana» – e non solo, verrebbe da dire. I titoli dei testi dicono già molto: La vita monastica come desiderio, Elogio dell’inutile, Deserto e solitudine, Formazione al silenzio, e così via. Non si cercheranno particolari approfondimenti in queste pagine, si troveranno bensì molti spunti, molti nomi (un po’ troppi, forse) e molte citazioni; e qualche interessante riflessione sull’accompagnamento spirituale: «L’eccessiva preoccupazione di sé non è indice di un cammino interiore ma può essere la manifestazione penosa e non riconosciuta del proprio narcisismo. Il direttore spirituale deve portare la persona guidata a specchiarsi in Cristo e non nel torbido dell’ego». Non sono d’accordo, ma questo non c’entra.
 Ernesto Buonaiuti, Francesco d’Assisi, Bietti 1939. La libertà del dilettante consente di non rinunciare a leggere libri che pure non rientrano nel novero degli «studi più recenti» o delle «ricerche più accreditate». Come nel caso di questo piccolo testo che cent’anni fa il grande Ernesto Buonaiuti ha approntato su san Francesco, nell’ambito della collana «Profili» (dapprima Formiggini, poi Bietti), una serie di «graziosi volumetti… tutti opera di autori di singolare competenza», intesi a offrire «vivaci, sintetiche e suggestive rievocazioni di figure attraenti e significative». Proprio così. Tra le righe di questo ritratto – scritte in un italiano che da solo vale la lettura – ci s’imbatte poi in osservazioni che vanno oltre la figura dello joculator Domini, il «giullare di Dio», quasi simbolo incarnato della vena più autentica e rivoluzionario-contraddittoria del cristianesimo; e d’altra parte «la società nominalmente cristiana ha sempre vissuto, nel suo secolare sviluppo, di una paradossale legge di contradizioni vicendevolmente compensatrici» (il corsivo è mio). La «minoranza infinitesimale» di Francesco (concetto che riassume splendidamente molte cose: l’esiguità del nucleo originale e il bisogno di «minorità», nonché l’attenzione all’assolutamente piccolo) trova la sua strada nel mondo delle «transazioni ufficiali» in forza di una superiore necessità, tanto che quando papa Innocenzo III diede la sua «approvazione provvisoria» alla nuova forma di vita «non ebbe davvero coscienza di aver autorizzato il più superbo tentativo di rinnovamento della prima vita evangelica, che da tredici secoli la società cristiana si fosse permesso». Inquadrato nelle visioni di Gioacchino da Fiore, il Francesco di Buonaiuti è un uomo solo, ma straniero a nessuno, amato oltre misura da un piccolo gruppo di testimoni diretti per la sua «semplicità irriflessa», il suo «entusiasmo di primitivo», il suo essere allo stesso tempo, perfettamente e lietamente, dentro il mondo e fuori di esso, come nessun altro mai dopo Gesù. L’immagine, suggerita da Buoniauti, che mi porterò dietro è questa, relativa al ritiro in solitudine sul monte Subasio: «Si diede a ramingare, solitario, nella campagna, addestrandosi al misterioso linguaggio delle creature minuscole o imponenti, esili o maestose, fragile ed effimere o resistenti ed eterne che popolano la natura disabitata dagli uomini, e che noi, nella nostra egocentrica angustia mentale e nella nostra inguaribile pigrizia psichica, definiamo inanimate o inintelligenti solo perché ci siamo sequestrati dal loro consorzio e ci siamo serrati alla loro ineffabile e suggestiva parola».
Ernesto Buonaiuti, Francesco d’Assisi, Bietti 1939. La libertà del dilettante consente di non rinunciare a leggere libri che pure non rientrano nel novero degli «studi più recenti» o delle «ricerche più accreditate». Come nel caso di questo piccolo testo che cent’anni fa il grande Ernesto Buonaiuti ha approntato su san Francesco, nell’ambito della collana «Profili» (dapprima Formiggini, poi Bietti), una serie di «graziosi volumetti… tutti opera di autori di singolare competenza», intesi a offrire «vivaci, sintetiche e suggestive rievocazioni di figure attraenti e significative». Proprio così. Tra le righe di questo ritratto – scritte in un italiano che da solo vale la lettura – ci s’imbatte poi in osservazioni che vanno oltre la figura dello joculator Domini, il «giullare di Dio», quasi simbolo incarnato della vena più autentica e rivoluzionario-contraddittoria del cristianesimo; e d’altra parte «la società nominalmente cristiana ha sempre vissuto, nel suo secolare sviluppo, di una paradossale legge di contradizioni vicendevolmente compensatrici» (il corsivo è mio). La «minoranza infinitesimale» di Francesco (concetto che riassume splendidamente molte cose: l’esiguità del nucleo originale e il bisogno di «minorità», nonché l’attenzione all’assolutamente piccolo) trova la sua strada nel mondo delle «transazioni ufficiali» in forza di una superiore necessità, tanto che quando papa Innocenzo III diede la sua «approvazione provvisoria» alla nuova forma di vita «non ebbe davvero coscienza di aver autorizzato il più superbo tentativo di rinnovamento della prima vita evangelica, che da tredici secoli la società cristiana si fosse permesso». Inquadrato nelle visioni di Gioacchino da Fiore, il Francesco di Buonaiuti è un uomo solo, ma straniero a nessuno, amato oltre misura da un piccolo gruppo di testimoni diretti per la sua «semplicità irriflessa», il suo «entusiasmo di primitivo», il suo essere allo stesso tempo, perfettamente e lietamente, dentro il mondo e fuori di esso, come nessun altro mai dopo Gesù. L’immagine, suggerita da Buoniauti, che mi porterò dietro è questa, relativa al ritiro in solitudine sul monte Subasio: «Si diede a ramingare, solitario, nella campagna, addestrandosi al misterioso linguaggio delle creature minuscole o imponenti, esili o maestose, fragile ed effimere o resistenti ed eterne che popolano la natura disabitata dagli uomini, e che noi, nella nostra egocentrica angustia mentale e nella nostra inguaribile pigrizia psichica, definiamo inanimate o inintelligenti solo perché ci siamo sequestrati dal loro consorzio e ci siamo serrati alla loro ineffabile e suggestiva parola».

 Guido Cariboni, I cistercensi. Un ordine monastico nel Medioevo, Carocci 2023.
Guido Cariboni, I cistercensi. Un ordine monastico nel Medioevo, Carocci 2023. John Chryssavgis, Al cuore del deserto. La spiritualità dei padri e delle madri del deserto, traduzione di C. Frescura, Edizioni Qiqajon, Comunità di Bose, 2004.
John Chryssavgis, Al cuore del deserto. La spiritualità dei padri e delle madri del deserto, traduzione di C. Frescura, Edizioni Qiqajon, Comunità di Bose, 2004. Trois jours et trois nuits. Le grand voyage des écrivains à l’abbaye de Lagrasse, préface de N. Diat, postface du père Emmanuel-Marie Le Fébure du Bus, Librairie Arthème Fayard / Pluriel 2021. «Dopo le recenti esperienze di confinamento, negli anni a venire forse proprio il chiostro sarà il nostro destino globale, se i viaggi e la mobilità saranno sempre più limitati da nuove pandemie o dalla paura di un aggravamento ulteriore della crisi climatica. Le piccole società monastiche, sobrie e autosufficienti, sarebbero quindi una prefigurazione del nostro futuro: quanto di più arcaico diventerebbe quanto mai attuale.» Così Pascal Bruckner riassume le sue riflessioni nel testo che apre il libro. Libro raccoglie i testi che quindici narratori, giornalisti, intellettuali francesi, «orchestrati» da Nicolas Diat, hanno scritto dopo aver passato il breve soggiorno indicato dal titolo presso i canonici agostiniani dell’
Trois jours et trois nuits. Le grand voyage des écrivains à l’abbaye de Lagrasse, préface de N. Diat, postface du père Emmanuel-Marie Le Fébure du Bus, Librairie Arthème Fayard / Pluriel 2021. «Dopo le recenti esperienze di confinamento, negli anni a venire forse proprio il chiostro sarà il nostro destino globale, se i viaggi e la mobilità saranno sempre più limitati da nuove pandemie o dalla paura di un aggravamento ulteriore della crisi climatica. Le piccole società monastiche, sobrie e autosufficienti, sarebbero quindi una prefigurazione del nostro futuro: quanto di più arcaico diventerebbe quanto mai attuale.» Così Pascal Bruckner riassume le sue riflessioni nel testo che apre il libro. Libro raccoglie i testi che quindici narratori, giornalisti, intellettuali francesi, «orchestrati» da Nicolas Diat, hanno scritto dopo aver passato il breve soggiorno indicato dal titolo presso i canonici agostiniani dell’ Raphaël Buyse, Un dio diverso, traduzione di L. Marino, Qiqajon-Comunità di Bose 2019 (trad. di Autrement, Dieu, 2019). L’autore, sacerdote, di questo piccolo libro ispirato («Ci sono libri che si divorano e altri che si assaporano lentamente. Un Dio diverso appartiene a entrambe le categorie», dice Enzo Bianchi) di giorni in un monastero (benedettino, belga) ne ha passati molti di più (tre anni) e così introduce il suo «resoconto»: «Quei pochi mesi passati al monastero di Clerlande mi hanno attirato in una strettoia. Hanno bruscamente interrotto il cammino che stavo facendo senza problemi da quasi sessant’anni. Più nulla è come prima. Né quello che sono, né quello che vorrei essere. E neanche quello che faccio. Quei pochi mesi di esperienza monastica hanno cambiato il corso della mia vita». Dopo anni di attività intensissima, la prolungata sosta presso una comunità di individui liberati da qualsiasi ambizione se non quella della ricerca di Dio («solidali, ma non intruppati») ha regalato a p. Buyse una prima scoperta: se interrogato direttamente, Dio tace («il suo silenzio mi ha mondato, purificato, disincrostato, strigliato, risciacquato, depurato. Mi ha cambiato, convertito, riformato e rifatto»). Prima scoperta sconvolgente e liberante, che lo ha portato a una seconda, altrettanto decisiva scoperta: «Senza tante chiacchiere, senza preconcetti ideologici e senza arroganza quei vecchi benedettini mi hanno rivelato quello che cercavano vivendo in quel luogo: l’unificazione profonda della persona». Ecco la vera scuola del monastero: l’essere umano, l’umanità («bisogna semplicemente credere nell’uomo. Nell’uomo amato da Dio»). E la comunità monastica diventa una specie di classe che accoglie scolari di tutte le età e provenienze, dove si studia, si mangia, si lavora, si prova in carne e ossa, insieme e con strumenti antichissimi, a contrastare la scissione che ci affligge, a inseguire giorno per giorno il desiderio di unità. Il Dio che parla, un Dio diverso appunto, non è altrove. «Ho compreso», scrive p. Buyse «che non c’è nulla da cercare altrove che nella profondità del quotidiano. […] Nella fragilità e nella grandezza del quotidiano si nasconde una profondità che ha il sapore dell’eternità: nell’uomo c’è qualcosa di più grande di lui. In questo io credo.» Eh, qualcosa…
Raphaël Buyse, Un dio diverso, traduzione di L. Marino, Qiqajon-Comunità di Bose 2019 (trad. di Autrement, Dieu, 2019). L’autore, sacerdote, di questo piccolo libro ispirato («Ci sono libri che si divorano e altri che si assaporano lentamente. Un Dio diverso appartiene a entrambe le categorie», dice Enzo Bianchi) di giorni in un monastero (benedettino, belga) ne ha passati molti di più (tre anni) e così introduce il suo «resoconto»: «Quei pochi mesi passati al monastero di Clerlande mi hanno attirato in una strettoia. Hanno bruscamente interrotto il cammino che stavo facendo senza problemi da quasi sessant’anni. Più nulla è come prima. Né quello che sono, né quello che vorrei essere. E neanche quello che faccio. Quei pochi mesi di esperienza monastica hanno cambiato il corso della mia vita». Dopo anni di attività intensissima, la prolungata sosta presso una comunità di individui liberati da qualsiasi ambizione se non quella della ricerca di Dio («solidali, ma non intruppati») ha regalato a p. Buyse una prima scoperta: se interrogato direttamente, Dio tace («il suo silenzio mi ha mondato, purificato, disincrostato, strigliato, risciacquato, depurato. Mi ha cambiato, convertito, riformato e rifatto»). Prima scoperta sconvolgente e liberante, che lo ha portato a una seconda, altrettanto decisiva scoperta: «Senza tante chiacchiere, senza preconcetti ideologici e senza arroganza quei vecchi benedettini mi hanno rivelato quello che cercavano vivendo in quel luogo: l’unificazione profonda della persona». Ecco la vera scuola del monastero: l’essere umano, l’umanità («bisogna semplicemente credere nell’uomo. Nell’uomo amato da Dio»). E la comunità monastica diventa una specie di classe che accoglie scolari di tutte le età e provenienze, dove si studia, si mangia, si lavora, si prova in carne e ossa, insieme e con strumenti antichissimi, a contrastare la scissione che ci affligge, a inseguire giorno per giorno il desiderio di unità. Il Dio che parla, un Dio diverso appunto, non è altrove. «Ho compreso», scrive p. Buyse «che non c’è nulla da cercare altrove che nella profondità del quotidiano. […] Nella fragilità e nella grandezza del quotidiano si nasconde una profondità che ha il sapore dell’eternità: nell’uomo c’è qualcosa di più grande di lui. In questo io credo.» Eh, qualcosa… Bernardo di Chiaravalle, Sermoni per l’anno liturgico / 2, introduzione, traduzione e note di D. Pezzini, Città Nuova 2021. Non si può passare sotto silenzio che lo scorso settembre, con la pubblicazione del secondo tomo del terzo volume dedicato ai Sermoni per l’anno liturgico, si è conclusa l’edizione delle «Opere di San Bernardo», avviata nel 1984 con il sostegno dell’Abbazia di Chiaravalle milanese e per la cura di Ferruccio Gastaldelli. Altre 950 pagine di san Bernardo, con testo latino a fronte, fitte delle sue parole più quotidiane, se così si può dire, quelle che rivolgeva ai «suoi» monaci quando poteva rientrare nella pace di Clairvaux «con l’animo affaticato da folle umane diverse che cercano cose diverse». A riprova del giacimento reso disponibile, apro (quasi) a caso una pagina, la 611, e cito dal Sermone agli abati: «Questo mare vasto – nel quale, in ogni caso, è certo che viene indicato niente altro se non il mondo presente, amaro e fluttuante – è transitabile da tre generi di uomini perché lo attraversino, ognuno a proprio modo, per uscirne liberi. Questi tre sono Noè, Daniele e Giobbe: di questi il primo lo attraversa in nave, il secondo su un ponte, il terzo a guado».
Bernardo di Chiaravalle, Sermoni per l’anno liturgico / 2, introduzione, traduzione e note di D. Pezzini, Città Nuova 2021. Non si può passare sotto silenzio che lo scorso settembre, con la pubblicazione del secondo tomo del terzo volume dedicato ai Sermoni per l’anno liturgico, si è conclusa l’edizione delle «Opere di San Bernardo», avviata nel 1984 con il sostegno dell’Abbazia di Chiaravalle milanese e per la cura di Ferruccio Gastaldelli. Altre 950 pagine di san Bernardo, con testo latino a fronte, fitte delle sue parole più quotidiane, se così si può dire, quelle che rivolgeva ai «suoi» monaci quando poteva rientrare nella pace di Clairvaux «con l’animo affaticato da folle umane diverse che cercano cose diverse». A riprova del giacimento reso disponibile, apro (quasi) a caso una pagina, la 611, e cito dal Sermone agli abati: «Questo mare vasto – nel quale, in ogni caso, è certo che viene indicato niente altro se non il mondo presente, amaro e fluttuante – è transitabile da tre generi di uomini perché lo attraversino, ognuno a proprio modo, per uscirne liberi. Questi tre sono Noè, Daniele e Giobbe: di questi il primo lo attraversa in nave, il secondo su un ponte, il terzo a guado». Les Bénédictins. La Règle de saint Benoît, traduction de la Règle réalisée par les moines de l’abbaye Saint-Wandrille, sous la direction de Daniel-Odon Hurel, Bouquins-Robert Laffont 2020. Volume ricchissimo che dà la Regola nel testo latino con traduzione francese e un assai esteso commento spirituale e storico, opera di un plotone di monaci benedettini e studiosi e studiose – quasi una raccolta di brevi e non tanto brevi saggi dedicati a ogni capitolo. 1340 pagine arricchite da un’utile «Chronologie de la dynamique bénédictine» e da un’utilissima «bibliografia cronologica» della Regola che, oltre all’elenco in ordine cronologico delle edizioni a stampa della medesima (40 pagine, dall’edizione tedesca del 1485/1490 di Memmingen, a quella italiana del 2011 a cura dei benedettini dell’Abbazia Madonna della Scala di Noci), offrono soprattutto l’elenco, sempre cronologico, dei commenti alla Regola, sempre a stampa (30 pagine scarse, dal commento di Juan de Torquemada, zio di quel Torquemada, stampato a Parigi nel 1491-94, a quello dottissimo di Aquinata Bockmann, in tre volumi, stampato a Parigi – toh – nel 2018 dalle Editions du Cerf) e l’elenco delle costituzioni degli ordini e delle congregazioni che «riconoscono Benedetto come patriarca» (altre 30 pagine affascinanti e utilissime di storia benedettina). Pur inserendosi nella lunga tradizione dei commenti, questo volume «segna un doppio scarto: non è firmato da un religioso o da un gruppo di monaci, ma è un’opera collettiva che riunisce docenti universitari e alcuni religiosi particolarmente competenti. Non è rivolto ai religiosi (senza che sia proibito loro di leggerlo!), bensì al pubblico il più vasto possibile, e per far ciò tenta una sintesi di undici secoli di riflessione sulla Regola con la percezione contemporanea del monachesimo cristiano» (dall’Introduzione di D.-O. Hurel).
Les Bénédictins. La Règle de saint Benoît, traduction de la Règle réalisée par les moines de l’abbaye Saint-Wandrille, sous la direction de Daniel-Odon Hurel, Bouquins-Robert Laffont 2020. Volume ricchissimo che dà la Regola nel testo latino con traduzione francese e un assai esteso commento spirituale e storico, opera di un plotone di monaci benedettini e studiosi e studiose – quasi una raccolta di brevi e non tanto brevi saggi dedicati a ogni capitolo. 1340 pagine arricchite da un’utile «Chronologie de la dynamique bénédictine» e da un’utilissima «bibliografia cronologica» della Regola che, oltre all’elenco in ordine cronologico delle edizioni a stampa della medesima (40 pagine, dall’edizione tedesca del 1485/1490 di Memmingen, a quella italiana del 2011 a cura dei benedettini dell’Abbazia Madonna della Scala di Noci), offrono soprattutto l’elenco, sempre cronologico, dei commenti alla Regola, sempre a stampa (30 pagine scarse, dal commento di Juan de Torquemada, zio di quel Torquemada, stampato a Parigi nel 1491-94, a quello dottissimo di Aquinata Bockmann, in tre volumi, stampato a Parigi – toh – nel 2018 dalle Editions du Cerf) e l’elenco delle costituzioni degli ordini e delle congregazioni che «riconoscono Benedetto come patriarca» (altre 30 pagine affascinanti e utilissime di storia benedettina). Pur inserendosi nella lunga tradizione dei commenti, questo volume «segna un doppio scarto: non è firmato da un religioso o da un gruppo di monaci, ma è un’opera collettiva che riunisce docenti universitari e alcuni religiosi particolarmente competenti. Non è rivolto ai religiosi (senza che sia proibito loro di leggerlo!), bensì al pubblico il più vasto possibile, e per far ciò tenta una sintesi di undici secoli di riflessione sulla Regola con la percezione contemporanea del monachesimo cristiano» (dall’Introduzione di D.-O. Hurel).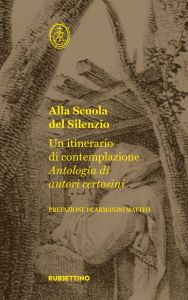 Alla scuola del silenzio. Un itinerario di contemplazione. Antologia di autori certosini, prefazione di A. Matteo, Rubbettino 2021. Graditissima nuova edizione, con titolo up to date, di un’antologia già apparsa nel 1987 dalle Paoline (e presentata allora dal cardinal Martini) e che inaugura la promettente collana dell’editore calabrese «Amore e silenzio. Voci», diretta da A. Cavallaro, T. Ceravolo e I. Iannizzotto. Il titolo parla da solo, il florilegio è organizzato per grandi aree tematiche, gli autori spaziano lungo gli oltre novecento anni di vita dell’Ordine e il volume (di 526 pagine) è corredato da estesi profili biografici e da un indice analitico degli argomenti singolare per precisione del dettaglio. Se cerco, ad esempio, «linguaggio», trovo che «la menzogna è il vuoto e il l. del nulla» e vengo rimandato a queste parole di Augustin Guillerand (dai suoi Ecrits spirituels, raccolti dopo la morte avvenuta nel 1945): «Si confonde il silenzio dell’Essere col silenzio del nulla. Ma il nulla non sa né parlare né tacere; sa soltanto agitarsi e mascherare, con dei movimenti superficiali, il vuoto che è in lui. Parole delle labbra alle quali non corrisponde alcun pensiero, atteggiamenti del corpo, mimica del volto che non traducono alcuna realtà o mentono realmente: ecco il linguaggio del nulla. Ed è per questo che lo moltiplica. Ci vogliono molte parole per non dire nulla o per dire ciò che non si pensa».
Alla scuola del silenzio. Un itinerario di contemplazione. Antologia di autori certosini, prefazione di A. Matteo, Rubbettino 2021. Graditissima nuova edizione, con titolo up to date, di un’antologia già apparsa nel 1987 dalle Paoline (e presentata allora dal cardinal Martini) e che inaugura la promettente collana dell’editore calabrese «Amore e silenzio. Voci», diretta da A. Cavallaro, T. Ceravolo e I. Iannizzotto. Il titolo parla da solo, il florilegio è organizzato per grandi aree tematiche, gli autori spaziano lungo gli oltre novecento anni di vita dell’Ordine e il volume (di 526 pagine) è corredato da estesi profili biografici e da un indice analitico degli argomenti singolare per precisione del dettaglio. Se cerco, ad esempio, «linguaggio», trovo che «la menzogna è il vuoto e il l. del nulla» e vengo rimandato a queste parole di Augustin Guillerand (dai suoi Ecrits spirituels, raccolti dopo la morte avvenuta nel 1945): «Si confonde il silenzio dell’Essere col silenzio del nulla. Ma il nulla non sa né parlare né tacere; sa soltanto agitarsi e mascherare, con dei movimenti superficiali, il vuoto che è in lui. Parole delle labbra alle quali non corrisponde alcun pensiero, atteggiamenti del corpo, mimica del volto che non traducono alcuna realtà o mentono realmente: ecco il linguaggio del nulla. Ed è per questo che lo moltiplica. Ci vogliono molte parole per non dire nulla o per dire ciò che non si pensa». Vincenzo Bonato, Introduzione al monachesimo, Nerbini 2021. L’Introduzione che il monaco camaldolese, studioso di teologia monastica e docente di Spiritualità ha pubblicato nella meritoria collana di «Orizzonti monastici» va intesa proprio come propedeutica all’idea di un reale «ingresso» in un monastero. Il testo infatti è organizzato in forma di lettera a un giovane che si senta attratto da una scelta di vita tanto lineare, all’apparenza, quanto complessa e non priva di pericoli nella sua concretezza, e si propone di illustrarne le caratteristiche: a cosa si va incontro, cosa ci si può aspettare, quali ne sono i fondamenti, i momenti costitutivi e quale ne è il significato autentico. Può essere la professione monastica la risposta a quel vago bisogno di spiritualità – termine sempre più difficile da arginare – che si attribuisce a molti giovani? Oltre a un meditato riepilogo dei principali aspetti della scelta di vita consacrata, prevedibili, in fondo, e non nuovi per chi frequenta la letteratura monastica contemporanea, e a una breve rassegna dei suoi «strumenti» primari, l’autore pone spesso l’accento sul carattere personale della vicenda o, come si tende a dire oggi, sulla sua dimensione esperienziale. Senza tradire la propria tradizione (o anzi, appunto, tradendola etimologicamente), la forza di attrazione della vita monastica non può che venire da monaci e monache in carne e ossa che mostrano agli aspiranti il senso, e gli esiti, di una scelta attraverso la loro testimonianza, il loro stile di vita abbracciato, amato e condiviso. La risposta a quel bisogno, la risposta stessa alla chiamata, quindi non può essere un’elaborazione concettuale, si potrebbe quasi dire che prima ancora di manifestarsi pienamente nella fede («Non è mai facile capire se la fede c’è o non c’è») è un «incontro personale», con il Signore anzitutto (tramite la Scrittura), ma anche con un individuo, con una comunità di individui. Individui che, all’inizio, possono vestire i panni di educatori, formatori, direttori spirituali, di maestri (la nostalgia dei quali oggi forse va di pari passo con tutte le difficoltà e anche le storture che possono sorgere da questo tipo di rapporti). Ecco allora che «il monastero presenta il vantaggio di offrirsi come luogo di vita e d’esperienza, in continuità. Perdura nel tempo, perché è animato da persone sagge, miti, sapienti più che dotte, pacificate nel cuore. Non è un luogo dove vengono elaborate teorie astratte, ma dove si manifesta un particolare stile di vita. Nella comunità monastica, lo stile di vita vale più di qualsiasi offerta culturale o catechetica».
Vincenzo Bonato, Introduzione al monachesimo, Nerbini 2021. L’Introduzione che il monaco camaldolese, studioso di teologia monastica e docente di Spiritualità ha pubblicato nella meritoria collana di «Orizzonti monastici» va intesa proprio come propedeutica all’idea di un reale «ingresso» in un monastero. Il testo infatti è organizzato in forma di lettera a un giovane che si senta attratto da una scelta di vita tanto lineare, all’apparenza, quanto complessa e non priva di pericoli nella sua concretezza, e si propone di illustrarne le caratteristiche: a cosa si va incontro, cosa ci si può aspettare, quali ne sono i fondamenti, i momenti costitutivi e quale ne è il significato autentico. Può essere la professione monastica la risposta a quel vago bisogno di spiritualità – termine sempre più difficile da arginare – che si attribuisce a molti giovani? Oltre a un meditato riepilogo dei principali aspetti della scelta di vita consacrata, prevedibili, in fondo, e non nuovi per chi frequenta la letteratura monastica contemporanea, e a una breve rassegna dei suoi «strumenti» primari, l’autore pone spesso l’accento sul carattere personale della vicenda o, come si tende a dire oggi, sulla sua dimensione esperienziale. Senza tradire la propria tradizione (o anzi, appunto, tradendola etimologicamente), la forza di attrazione della vita monastica non può che venire da monaci e monache in carne e ossa che mostrano agli aspiranti il senso, e gli esiti, di una scelta attraverso la loro testimonianza, il loro stile di vita abbracciato, amato e condiviso. La risposta a quel bisogno, la risposta stessa alla chiamata, quindi non può essere un’elaborazione concettuale, si potrebbe quasi dire che prima ancora di manifestarsi pienamente nella fede («Non è mai facile capire se la fede c’è o non c’è») è un «incontro personale», con il Signore anzitutto (tramite la Scrittura), ma anche con un individuo, con una comunità di individui. Individui che, all’inizio, possono vestire i panni di educatori, formatori, direttori spirituali, di maestri (la nostalgia dei quali oggi forse va di pari passo con tutte le difficoltà e anche le storture che possono sorgere da questo tipo di rapporti). Ecco allora che «il monastero presenta il vantaggio di offrirsi come luogo di vita e d’esperienza, in continuità. Perdura nel tempo, perché è animato da persone sagge, miti, sapienti più che dotte, pacificate nel cuore. Non è un luogo dove vengono elaborate teorie astratte, ma dove si manifesta un particolare stile di vita. Nella comunità monastica, lo stile di vita vale più di qualsiasi offerta culturale o catechetica».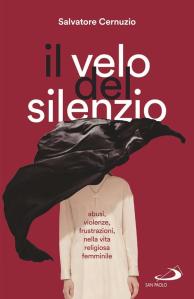 Queste parole, cui anche il non credente presta ascolto e rispetto, risuonano ancora quando si chiude l’ultima pagina del libro di Salvatore Cernuzio, Il velo del silenzio. Abusi, violenze, frustrazioni nella vita religiosa femminile, San Paolo 2021. Di questa materia può parlare solo chi ne ha esperienza diretta, in quanto vittima, testimone o esperto a vario titolo, quindi mi limito ad annotare che questo libro esiste e raccoglie undici testimonianze anonime di religiose (lo specifico femminile è cruciale) che hanno sofferto di abusi, principalmente, salvo un caso, di potere e di coscienza, e hanno lasciato le comunità in cui avevano scelto di consacrare la loro esistenza. Le testimonianze sono accompagnate da un «dispiegamento di forze» assai eloquente: una prefazione di Nathalie Becquart, saveriana, sottosegretaria del Sinodo dei Vescovi («Dobbiamo ascoltarle [queste testimonianze], sentirle e prendere coscienza che la vita consacrata nella sua diversità, come altre realtà ecclesiali, può generare sia il meglio che il peggio»), un’introduzione del gesuita Giovanni Cucci, che all’argomento aveva dedicato un importante articolo su «La Civiltà Cattolica» nel settembre 2020 («Va lodato e incoraggiato chi ha deciso, non senza sofferenze e resistenze, di rompere il muro del silenzio, che è di fatto il canale privilegiato di diffusione del male»), un’intervista allo psichiatra e psicoterapeuta Tonino Cantelmi («Direi che nelle congregazioni maschili può prevalere una forma di individualismo controvocazionale, dove il conflitto è celato dal rispetto tacito dei reciproci spazi; in quelle femminili è più probabile che si nascondano forme sommerse di sofferenza e solitudini atroci in apparenti comunità attive») e un intervento del canonista Giorgio Giovanelli sugli aspetti teologici e giuridici dell’obbedienza («Se tutti i cristiani sono tenuti all’obbedienza alla Parola di Dio, l’obbedienza del religioso passa attraverso precise mediazioni umane»).
Queste parole, cui anche il non credente presta ascolto e rispetto, risuonano ancora quando si chiude l’ultima pagina del libro di Salvatore Cernuzio, Il velo del silenzio. Abusi, violenze, frustrazioni nella vita religiosa femminile, San Paolo 2021. Di questa materia può parlare solo chi ne ha esperienza diretta, in quanto vittima, testimone o esperto a vario titolo, quindi mi limito ad annotare che questo libro esiste e raccoglie undici testimonianze anonime di religiose (lo specifico femminile è cruciale) che hanno sofferto di abusi, principalmente, salvo un caso, di potere e di coscienza, e hanno lasciato le comunità in cui avevano scelto di consacrare la loro esistenza. Le testimonianze sono accompagnate da un «dispiegamento di forze» assai eloquente: una prefazione di Nathalie Becquart, saveriana, sottosegretaria del Sinodo dei Vescovi («Dobbiamo ascoltarle [queste testimonianze], sentirle e prendere coscienza che la vita consacrata nella sua diversità, come altre realtà ecclesiali, può generare sia il meglio che il peggio»), un’introduzione del gesuita Giovanni Cucci, che all’argomento aveva dedicato un importante articolo su «La Civiltà Cattolica» nel settembre 2020 («Va lodato e incoraggiato chi ha deciso, non senza sofferenze e resistenze, di rompere il muro del silenzio, che è di fatto il canale privilegiato di diffusione del male»), un’intervista allo psichiatra e psicoterapeuta Tonino Cantelmi («Direi che nelle congregazioni maschili può prevalere una forma di individualismo controvocazionale, dove il conflitto è celato dal rispetto tacito dei reciproci spazi; in quelle femminili è più probabile che si nascondano forme sommerse di sofferenza e solitudini atroci in apparenti comunità attive») e un intervento del canonista Giorgio Giovanelli sugli aspetti teologici e giuridici dell’obbedienza («Se tutti i cristiani sono tenuti all’obbedienza alla Parola di Dio, l’obbedienza del religioso passa attraverso precise mediazioni umane»). Hubert Bienvenu, Moine ou moniale? Qui es-tu? À quoi sers-tu?, France-Empire 2021. Devo confessare che mi aspettavo qualcosa di più, in virtù soprattutto di un sottotitolo che recita «Difesa e delucidazione della vita monastica», e tuttavia mi sono detto che forse anche queste brevi introduzioni al fatto monastico sono «necessarie» e possono essere utili. Sono, poi, anche sintomatiche, giacché se ne continua a scrivere e a pubblicare: devono dunque essere effetivamente difesi gli esseri umani che fanno, oggi, quella scelta? Da quali accuse? E da quale posizione possono essere accusati, cioè da chi e in nome di cosa? So che dietro queste domande può essere individuata una pericolosa forma di relativizzazione, pericolosa per i religiosi, s’intende: rispettare questa forma di vita come una delle tante possibili e legittime significa infatti togliere a essa la sua assoluta specificità. Questo è un problema che non posso che lasciare ai monaci stessi, che peraltro, mi pare, raramente si avventurano in «difese» della propria professione. In fondo, che ci abbia provato un giornalista e saggista laico, non mi sembra privo di significato. Monaci e monache per Bienvenu sono i testimoni più «evidenti» dell’amore di Dio per l’umanità e del bisogno di ricambiare tale amore: nata con il cristianesimo delle origini (e qui sarebbe interessante approfondire quella che definisco la «questione quantitativa», cioè il rapporto tra vocazione ed estensione numerica della comunità in cui essa può fiorire), «l’istituzione monastica è sempre sopravvissuta. Strettamente connessa al mistero della Chiesa, ha attraversato i secoli perché si richiama a esigenze e valori che trascendono il tempo. Dio non cambia, le parole di Cristo non passano, e l’uomo vorrà sempre “cercare Dio” in un incontro d’amore individuale. La vocazione monastica è, in questo senso, atemporale, e monaci e monache ci saranno anche domani, senza alcun dubbio».
Hubert Bienvenu, Moine ou moniale? Qui es-tu? À quoi sers-tu?, France-Empire 2021. Devo confessare che mi aspettavo qualcosa di più, in virtù soprattutto di un sottotitolo che recita «Difesa e delucidazione della vita monastica», e tuttavia mi sono detto che forse anche queste brevi introduzioni al fatto monastico sono «necessarie» e possono essere utili. Sono, poi, anche sintomatiche, giacché se ne continua a scrivere e a pubblicare: devono dunque essere effetivamente difesi gli esseri umani che fanno, oggi, quella scelta? Da quali accuse? E da quale posizione possono essere accusati, cioè da chi e in nome di cosa? So che dietro queste domande può essere individuata una pericolosa forma di relativizzazione, pericolosa per i religiosi, s’intende: rispettare questa forma di vita come una delle tante possibili e legittime significa infatti togliere a essa la sua assoluta specificità. Questo è un problema che non posso che lasciare ai monaci stessi, che peraltro, mi pare, raramente si avventurano in «difese» della propria professione. In fondo, che ci abbia provato un giornalista e saggista laico, non mi sembra privo di significato. Monaci e monache per Bienvenu sono i testimoni più «evidenti» dell’amore di Dio per l’umanità e del bisogno di ricambiare tale amore: nata con il cristianesimo delle origini (e qui sarebbe interessante approfondire quella che definisco la «questione quantitativa», cioè il rapporto tra vocazione ed estensione numerica della comunità in cui essa può fiorire), «l’istituzione monastica è sempre sopravvissuta. Strettamente connessa al mistero della Chiesa, ha attraversato i secoli perché si richiama a esigenze e valori che trascendono il tempo. Dio non cambia, le parole di Cristo non passano, e l’uomo vorrà sempre “cercare Dio” in un incontro d’amore individuale. La vocazione monastica è, in questo senso, atemporale, e monaci e monache ci saranno anche domani, senza alcun dubbio». Adalbert de Vogüé, San Benedetto. Uomo di Dio, traduzione di M. Magnatti Fasiolo, San Paolo 1999 (trad. Saint Benoît, Homme de Dieu, 1993). Il grande studioso (e monaco) benedettino riracconta il racconto della vita di san Benedetto fatto da Gregorio Magno (nel secondo libro dei Dialoghi). È un piacevole ripasso, non privo però di notazioni che esulano dalla dimensione, appunto, del ripasso, e che soprattutto mi ha ricordato come la clamorosa affermazione di san Benedetto e la diffusione della sua Regola non siano state esenti da una certa «fortuna»: «La fortuna di Benedetto, se così si può dire, fu di essere scelto come eroe di una biografia completa dal miglior scrittore del suo secolo e uno dei più grandi papi che abbia mai avuto la Chiesa… Immaginiamo che Giovanni Paolo II, tra due viaggi, trovi il tempo di scrivere la vita di un santo, per esempio di quel Massimiliano Kolbe che fu suo compatriota e morì cinquant’anni fa. Supponiamo che il nostro papa ci metta del talento e riesca a dare di quel religioso martire un’immagine insieme storicamente vera e spiritualmente vibrante, nella quale il popolo cristiano di oggi riconosca il suo ideale, riviva il suo dramma collettivo, senta passare la grazia di Dio. Tale fu la “fortuna” di san Benedetto». Non posso fare a meno, poi, di citare una battuta che de Vogüé si concede introducendo l’episodio della prima vestizione di Benedetto a Subiaco: «Contrariamente a un proverbio troppo ripetuto, l’abito fa il monaco. Non che basti, ma è indispensabile». Ovviamente non si tratta solo di Benedetto né semplicemente di un vestito, «ma di ricevere con esso tutto ciò che significa: la vita religiosa, com’è stata concepita, sperimentata, praticata da generazioni di monaci e com’è attualmente vissuta dai rappresentanti di questa tradizione».
Adalbert de Vogüé, San Benedetto. Uomo di Dio, traduzione di M. Magnatti Fasiolo, San Paolo 1999 (trad. Saint Benoît, Homme de Dieu, 1993). Il grande studioso (e monaco) benedettino riracconta il racconto della vita di san Benedetto fatto da Gregorio Magno (nel secondo libro dei Dialoghi). È un piacevole ripasso, non privo però di notazioni che esulano dalla dimensione, appunto, del ripasso, e che soprattutto mi ha ricordato come la clamorosa affermazione di san Benedetto e la diffusione della sua Regola non siano state esenti da una certa «fortuna»: «La fortuna di Benedetto, se così si può dire, fu di essere scelto come eroe di una biografia completa dal miglior scrittore del suo secolo e uno dei più grandi papi che abbia mai avuto la Chiesa… Immaginiamo che Giovanni Paolo II, tra due viaggi, trovi il tempo di scrivere la vita di un santo, per esempio di quel Massimiliano Kolbe che fu suo compatriota e morì cinquant’anni fa. Supponiamo che il nostro papa ci metta del talento e riesca a dare di quel religioso martire un’immagine insieme storicamente vera e spiritualmente vibrante, nella quale il popolo cristiano di oggi riconosca il suo ideale, riviva il suo dramma collettivo, senta passare la grazia di Dio. Tale fu la “fortuna” di san Benedetto». Non posso fare a meno, poi, di citare una battuta che de Vogüé si concede introducendo l’episodio della prima vestizione di Benedetto a Subiaco: «Contrariamente a un proverbio troppo ripetuto, l’abito fa il monaco. Non che basti, ma è indispensabile». Ovviamente non si tratta solo di Benedetto né semplicemente di un vestito, «ma di ricevere con esso tutto ciò che significa: la vita religiosa, com’è stata concepita, sperimentata, praticata da generazioni di monaci e com’è attualmente vissuta dai rappresentanti di questa tradizione».







