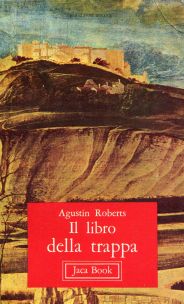 Come nella migliore tradizione la vicenda è cominciata con un libro adocchiato su una bancarella. Figuriamoci: Il libro della trappa, di un tale Agustín Roberts1, comprato all’istante, anche con lo stupore che esistesse un libro con un titolo del genere – che infatti si rivelerà essere un «titolo editoriale» di un originale ben diverso, Hacia Cristo. Apertolo all’impiedi davanti alla bancarella medesima, si è presentato con un’avvertenza dal tono e soprattutto dal contenuto assai singolari, che hanno acceso immediatamente il mio interesse. Nella «Nota di edizione» a pagina 9 ho letto infatti che le suore trappiste di Vitorchiano avevano contattato l’editore circa la possibilità di pubblicare in italiano il libretto, assai utile per le postulanti, che loro lo «avrebbero anche semplicemente ciclostilato in un numero limitato di copie»; l’editore aveva letto e valutato, e scoperto che il testo «forse più di ogni altro poteva far conoscere in cosa consiste lo svolgersi quotidiano della vita contemplativa».
Come nella migliore tradizione la vicenda è cominciata con un libro adocchiato su una bancarella. Figuriamoci: Il libro della trappa, di un tale Agustín Roberts1, comprato all’istante, anche con lo stupore che esistesse un libro con un titolo del genere – che infatti si rivelerà essere un «titolo editoriale» di un originale ben diverso, Hacia Cristo. Apertolo all’impiedi davanti alla bancarella medesima, si è presentato con un’avvertenza dal tono e soprattutto dal contenuto assai singolari, che hanno acceso immediatamente il mio interesse. Nella «Nota di edizione» a pagina 9 ho letto infatti che le suore trappiste di Vitorchiano avevano contattato l’editore circa la possibilità di pubblicare in italiano il libretto, assai utile per le postulanti, che loro lo «avrebbero anche semplicemente ciclostilato in un numero limitato di copie»; l’editore aveva letto e valutato, e scoperto che il testo «forse più di ogni altro poteva far conoscere in cosa consiste lo svolgersi quotidiano della vita contemplativa».
E qui la nota prendeva una piega inattesa. L’editore infatti riteneva che il testo potesse essere di grande utilità a «tutti coloro che con onestà vogliono fare un passo nella comprensione di un avvenimento che questa società vorrebbe emarginare, ma che di fatto è inemarginabile. L’inemarginabile dall’ideologia di questo mondo è in fondo il contenuto di questo libro». Perbacco! Anche se penso che oggi, passati altri cinquant’anni da quelle parole, «questo mondo» (ammesso che esista una concreta entità corrispondente a tale concetto) in realtà non voglia «emarginare» il monachesimo, ma sia in sostanza indifferente al suo destino (a patto che si possano visitare i monasteri e i relativi gift shop abbiano un orario decente), l’affermazione non poteva non colpirmi.
La prefazione dell’autore, che seguiva la nota dell’editore, affermava che si trattava di «uno studio sul significato dei voti monastici, precisamente come espressione della dinamica benedettino-cistercense. Poiché questa dinamica contemplativa è nel cuore di ogni uomo, speriamo che esse siano di profitto generale». La prefazione era datata «Azul, 1970», cioè, come ho appreso in seguito, dal monastero trappista di Nuestra Señora de Los Ángeles di Azul, a circa 300 chilometri a sud di Buenos Aires, del quale p. Roberts era stato abate dal 2000 al 2008, dopo essere stato per quattro anni procuratore generale dei cistercensi della stretta osservanza presso la Santa Sede.
Insomma, Agustín Roberts, nato Bruce nel 1932, quindi John nel 1953, novizio presso l’abbazia di Spencer, nel Massachussetts, e infine Augustine (poiché c’era un altro John nel monastero) monaco professo nel 1958 «è stato una delle figure più significative e influenti del monachesimo cistercense della seconda metà del XX secolo, quasi sconosciuto al di fuori del suo Ordine». E qualche mese dopo avevo in mano Configurati a Cristo, il corposo volume di 450 pagine2 che rappresenta il punto di arrivo di numerose edizioni e revisioni di quel primo testo, nato in forma di appunti nel 1967, e la cui lettura è stata di estremo interesse e utilità per cogliere dall’interno gli aspetti più importanti di quella che ancora e sempre pare una scelta di difficile comprensione.
Ma a questo punto è lecito domandarsi: Augustine Roberts, chi era costui?
(1-segue)
______
- Agustín Roberts, Il libro della trappa. Orientamenti pratico-dottrinali sulla professione monastica, traduzione di F. Mazzariol, Jaca Book 1976.
- Augustine Roberts, Configurati a Cristo. Una guida alla professione monastica, Nerbini, «Quaderni di Valserena», 2018.

 (la prima parte è
(la prima parte è  Nonostante siano passati quasi cinquant’anni dalla sua pubblicazione, o forse proprio per questo motivo, il libro che Georges Duby ha dedicato all’arte cistercense (e a san Bernardo) si legge con grande piacere, e direi anche con grande profitto1. Il piacere è dovuto in gran parte al testo vero e proprio, steso in uno stile storiografico sempre meno frequentato che non rinuncia, in nome della precisione e del rigore, a un evidente impulso narrativo, sfrondato dagli apparati, che lo rende «appassionante»; mentre il profitto deriva dal fatto che la lettura di Duby del fenomeno artistico cistercense, eminentemente architettonico, potrà anche essere datata e da aggiornare (io però non lo so), ma non può essere di certo del tutto fuori fuoco.
Nonostante siano passati quasi cinquant’anni dalla sua pubblicazione, o forse proprio per questo motivo, il libro che Georges Duby ha dedicato all’arte cistercense (e a san Bernardo) si legge con grande piacere, e direi anche con grande profitto1. Il piacere è dovuto in gran parte al testo vero e proprio, steso in uno stile storiografico sempre meno frequentato che non rinuncia, in nome della precisione e del rigore, a un evidente impulso narrativo, sfrondato dagli apparati, che lo rende «appassionante»; mentre il profitto deriva dal fatto che la lettura di Duby del fenomeno artistico cistercense, eminentemente architettonico, potrà anche essere datata e da aggiornare (io però non lo so), ma non può essere di certo del tutto fuori fuoco. La sapienza del cuore1 rappresenta uno degli esempi più tipici di quei libri di «cose monastiche» che non leggo per motivi di conoscenza storica e inquadramento di un fenomeno culturale bensì per… per cosa? Come definire lo scopo di una lettura del genere senza ipocrisia né autocompiacimento? Forse la formulazione più onesta è quella di «conoscenza personale»; forse si può persino rispolverare il concetto di «edificazione». Poi, con una punta – in questo caso sì – di condiscendenza verso le mie fantasie, posso immaginare di essere seduto tra gli uditori dei sermoni di san Bernardo ed esserne chiamato direttamente in causa. Oggi.
La sapienza del cuore1 rappresenta uno degli esempi più tipici di quei libri di «cose monastiche» che non leggo per motivi di conoscenza storica e inquadramento di un fenomeno culturale bensì per… per cosa? Come definire lo scopo di una lettura del genere senza ipocrisia né autocompiacimento? Forse la formulazione più onesta è quella di «conoscenza personale»; forse si può persino rispolverare il concetto di «edificazione». Poi, con una punta – in questo caso sì – di condiscendenza verso le mie fantasie, posso immaginare di essere seduto tra gli uditori dei sermoni di san Bernardo ed esserne chiamato direttamente in causa. Oggi. Considero salutare, per il mio modesto impegno di comprensione, misurarmi con testi come Il sole nella notte di Bernardo Olivera1. Un testo impegnativo e istruttivo, il cui argomento si estende molto oltre la mia capacità di riferirne (e in fondo anche di accoglierne le premesse). Come infatti recita il sottotitolo, il libro del monaco argentino, abate generale dei Trappisti dal 1990 al 2008, parla di «mistica cristiana ed esperienza monastica», con particolare riferimento alla tradizione di autori e autrici cisterciensi.
Considero salutare, per il mio modesto impegno di comprensione, misurarmi con testi come Il sole nella notte di Bernardo Olivera1. Un testo impegnativo e istruttivo, il cui argomento si estende molto oltre la mia capacità di riferirne (e in fondo anche di accoglierne le premesse). Come infatti recita il sottotitolo, il libro del monaco argentino, abate generale dei Trappisti dal 1990 al 2008, parla di «mistica cristiana ed esperienza monastica», con particolare riferimento alla tradizione di autori e autrici cisterciensi. Di grande interesse il numero più recente di
Di grande interesse il numero più recente di 