 Sono disponibili in traduzione italiana le Vite dei Padri di Gregorio di Tours1 (attivo nella seconda metà del VI secolo e assai noto soprattutto per la sua Storia dei Franchi), anzi, come precisa l’autore stesso citando Plinio, «“gli antichi parlano delle vite di ciascuno di noi, ma i grammatici non credono che il termine vita abbia un plurale”. Quindi è chiaro che è meglio parlare di vita dei Padri, che non di vite dei Padri, poiché, anche se vi è diversità di meriti e di virtù, tuttavia una sola Vita li mantiene in questo mondo».
Sono disponibili in traduzione italiana le Vite dei Padri di Gregorio di Tours1 (attivo nella seconda metà del VI secolo e assai noto soprattutto per la sua Storia dei Franchi), anzi, come precisa l’autore stesso citando Plinio, «“gli antichi parlano delle vite di ciascuno di noi, ma i grammatici non credono che il termine vita abbia un plurale”. Quindi è chiaro che è meglio parlare di vita dei Padri, che non di vite dei Padri, poiché, anche se vi è diversità di meriti e di virtù, tuttavia una sola Vita li mantiene in questo mondo».
Mi fa sempre bene ripassare le formule e gli stereotipi della letteratura agiografica (in questo caso altomedievale): febbri spente; ciechi che recuperano la vista grazie alla santa saliva; zoppi, sordi, muti e contratti: tutti guariti; cadaveri incorrotti; un sacco di pustole e di morsi curati; dita in bocca per «estrarre» Satana dagli indemoniati (per farli, cioè, vomitare il male); tombe che esalano profumo e che spandono miracoli, tra i quali quello di rallegrare i tristi; criminali ravveduti; re rabboniti; reliquie contese; brandelli miracolosi di abiti (e anche zolle della terra di sepoltura); lampade che non si spengono tutta la notte; otri che non si svuotano; reti che si riempiono di pesci; incendi che distruggono tutto tranne la santa reliquia…
Qui, poi, trova ampio spazio il motivo dell’abbandono del consesso umano a favore della montagna, della foresta, del «deserto»: fratelli che si spostarono nei luoghi remoti del deserto del Giura; piccoli monasteri che sorgono una volta abbattuta e spianata la foresta; un monaco che, entrato nella profonda solitudine della selva… vi costruì una cella; il monaco che, dimenticando la sua patria e i suoi genitori, andò in cerca del deserto; i santi che si ritirarono nelle lande più incolte; il recluso che, preso un piccone, scavò la pietra della cella in cui si trovava per ingrandirla…
Si possono trovare anche piccoli episodi che esulano dal canone e che hanno un forte sapore di realtà: i monaci che ci restarono molto male quando il loro abate li obbligò a mangiare un semplice minestrone [pultis]; i barbari, pagani, della regione che «lì adoravano i propri idoli come dèi e deponevano delle immagini di membra umane scolpite nel legno, quando una parte del corpo era colpita da malattia». Talvolta l’agiografo, per così dire, non sa dove sbattere la testa e riporta «miracoli» appena passabili: il santo che guarisce la mano della ragazza che si era ferita acconciandosi i capelli, «credo che si ferì perché si stava pettinando in un giorno santo»; il recluso che scaccia uno sciame di vespe col segno della croce; il futuro vescovo nato già con la chierica e che anni dopo cerca di togliersi un fastidio dietro al collo, senza riuscirvi: «Voltando il capo a destra e a sinistra, annusò un dolce odore e capì che questo fardello era quello della dignità episcopale»; il vescovo Niceto che «un giorno, mentre era in viaggio, scese da cavallo per fare i suoi bisogni e andò in una fitta boscaglia [descendens ab equo, inter vepres condensas ventris purgandi gratia est ingressus]» dove un terribile serpente quasi lo divora, prima di essere messo in fuga dal segno della croce…
Anche i nomi, mia inossidabile passione, sono spesso memorabili: Illidio, taumaturgo di Clermont; il vescovo Apruncolo, il duca Hilpingo e il funzionario Lytigio; Friardo e Clappano, reclusi abitatori delle foreste; la tentatrice Leubella; il monastero di Mascarpion; l’abate Leobazio; persino gli indemoniati, eccezionalmente, hanno un nome: «Lupo, Teodulfo, Rucco, Scopilia, Nectariola e Tachilde furono purificati presso la tomba del santo»…
Nella rassegna di Gregorio c’è posto per una sola donna dalla parte dei «buoni», Monegunda, santa e taumaturga («L’Onnipotente] ci dà come modelli non solo uomini robusti, ma anche il sesso debole [inferiorem sexum], che lotta non debolmente ma con vigore virile»). Originaria di Chartres, Monegunda si sposa, «secondo il desiderio dei suoi genitori», e dà alla luce due figlie, che però le «furono portate via da una leggera febbre». Allora, passato il lutto, si «fece fare una cella con una sola finestrella» dove occuparsi soltanto di Dio. Ma la sua fama si diffonde, e cominciano i miracoli. Per non cadere nella vanagloria Monegunda se ne va a Tours; il marito, sensibile alla fama della «santa», la insegue e la riporta a casa; lei scappa di nuovo e torna a Tours; il marito si rassegna; lei raduna alcune donne e fonda un piccolo monastero. E ricominciano i miracoli, soprattutto le guarigioni, che si moltiplicano innumerevoli sulla sua tomba: «Che dire di tanti altri che sono stati guariti dalla febbre solo per aver baciato con fede il drappo che ricopre il sepolcro della santa? Che dire degli indemoniati che, portati nella sua cella, appena varcata la soglia già avevano recuperata la ragione?»
Che dire? «Non abbiamo visto tutte le cose di cui abbiamo scritto», precisa Gregorio, «ma alcune ci sono state confermate da certi racconti, alcune dalla testimonianza di autori approvati e altre le abbiamo viste con i nostri occhi», e che questi santi siano stati ammessi nella compagnia dei giusti «credo che nessuno dei fedeli possa dubitarne».
______
- Gregorio di Tours, Paterikon delle Gallie. Tra foreste e monasteri nella Francia dei primi secoli, a cura di A.M. Osenga [che nell’introduzione non rinuncia, ancora, a una frecciata contro la Francia «dei Lumi»], Monasterium 2024.

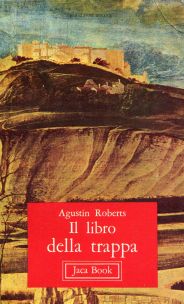 Come nella migliore tradizione la vicenda è cominciata con un libro adocchiato su una bancarella. Figuriamoci: Il libro della trappa, di un tale Agustín Roberts1, comprato all’istante, anche con lo stupore che esistesse un libro con un titolo del genere – che infatti si rivelerà essere un «titolo editoriale» di un originale ben diverso, Hacia Cristo. Apertolo all’impiedi davanti alla bancarella medesima, si è presentato con un’avvertenza dal tono e soprattutto dal contenuto assai singolari, che hanno acceso immediatamente il mio interesse. Nella «Nota di edizione» a pagina 9 ho letto infatti che le suore trappiste di Vitorchiano avevano contattato l’editore circa la possibilità di pubblicare in italiano il libretto, assai utile per le postulanti, che loro lo «avrebbero anche semplicemente ciclostilato in un numero limitato di copie»; l’editore aveva letto e valutato, e scoperto che il testo «forse più di ogni altro poteva far conoscere in cosa consiste lo svolgersi quotidiano della vita contemplativa».
Come nella migliore tradizione la vicenda è cominciata con un libro adocchiato su una bancarella. Figuriamoci: Il libro della trappa, di un tale Agustín Roberts1, comprato all’istante, anche con lo stupore che esistesse un libro con un titolo del genere – che infatti si rivelerà essere un «titolo editoriale» di un originale ben diverso, Hacia Cristo. Apertolo all’impiedi davanti alla bancarella medesima, si è presentato con un’avvertenza dal tono e soprattutto dal contenuto assai singolari, che hanno acceso immediatamente il mio interesse. Nella «Nota di edizione» a pagina 9 ho letto infatti che le suore trappiste di Vitorchiano avevano contattato l’editore circa la possibilità di pubblicare in italiano il libretto, assai utile per le postulanti, che loro lo «avrebbero anche semplicemente ciclostilato in un numero limitato di copie»; l’editore aveva letto e valutato, e scoperto che il testo «forse più di ogni altro poteva far conoscere in cosa consiste lo svolgersi quotidiano della vita contemplativa». Sì, d’accordo, i classici, però «in verità, quando si siano letti e riletti con grandissima passione e fatica, null’altro lasciano ai lettori se non vacua sonorità e rumor di parole» (Girolamo); diamogli comunque una letta, perché «se hanno detto per caso qualcosa di vero e conforme alla nostra fede… lo si deve rivendicare per il nostro uso» (Agostino). E se qualcuno «non saprà leggere, alle ore prima, terza e sesta andrà da chi lo può istruire… e, anche se non vuole, sarà costretto a leggere» (Pacomio) almeno qualcuno dei libri «che vi ho lasciato in unico armadio» (Cassiodoro). Occhio che «se qualcuno ordisca o tenti di sottrarre… anche uno solo di questi libri sopra elencati, non abbia parte nella resurrezione dei giusti, ma abbia parte con quelli che, posti alla sinistra, saranno dannati al fuoco eterno» (cod. Casin. 57).
Sì, d’accordo, i classici, però «in verità, quando si siano letti e riletti con grandissima passione e fatica, null’altro lasciano ai lettori se non vacua sonorità e rumor di parole» (Girolamo); diamogli comunque una letta, perché «se hanno detto per caso qualcosa di vero e conforme alla nostra fede… lo si deve rivendicare per il nostro uso» (Agostino). E se qualcuno «non saprà leggere, alle ore prima, terza e sesta andrà da chi lo può istruire… e, anche se non vuole, sarà costretto a leggere» (Pacomio) almeno qualcuno dei libri «che vi ho lasciato in unico armadio» (Cassiodoro). Occhio che «se qualcuno ordisca o tenti di sottrarre… anche uno solo di questi libri sopra elencati, non abbia parte nella resurrezione dei giusti, ma abbia parte con quelli che, posti alla sinistra, saranno dannati al fuoco eterno» (cod. Casin. 57). Sandro Carotta, Alla ricerca della bellezza. Percorsi monastici, Nerbini 2023 («Orizzonti monastici»; 48). Il famoso e prolifico benedettino di Praglia ha raccolto in questo volumetto della rinata serie degli «Orizzonti monastici» scritti e contributi di varia dimensione e occasione, «indirizzati a tanti uomini e donne che, sempre più numerosi, cercano nei monasteri un punto di riferimento per la loro vita cristiana» – e non solo, verrebbe da dire. I titoli dei testi dicono già molto: La vita monastica come desiderio, Elogio dell’inutile, Deserto e solitudine, Formazione al silenzio, e così via. Non si cercheranno particolari approfondimenti in queste pagine, si troveranno bensì molti spunti, molti nomi (un po’ troppi, forse) e molte citazioni; e qualche interessante riflessione sull’accompagnamento spirituale: «L’eccessiva preoccupazione di sé non è indice di un cammino interiore ma può essere la manifestazione penosa e non riconosciuta del proprio narcisismo. Il direttore spirituale deve portare la persona guidata a specchiarsi in Cristo e non nel torbido dell’ego». Non sono d’accordo, ma questo non c’entra.
Sandro Carotta, Alla ricerca della bellezza. Percorsi monastici, Nerbini 2023 («Orizzonti monastici»; 48). Il famoso e prolifico benedettino di Praglia ha raccolto in questo volumetto della rinata serie degli «Orizzonti monastici» scritti e contributi di varia dimensione e occasione, «indirizzati a tanti uomini e donne che, sempre più numerosi, cercano nei monasteri un punto di riferimento per la loro vita cristiana» – e non solo, verrebbe da dire. I titoli dei testi dicono già molto: La vita monastica come desiderio, Elogio dell’inutile, Deserto e solitudine, Formazione al silenzio, e così via. Non si cercheranno particolari approfondimenti in queste pagine, si troveranno bensì molti spunti, molti nomi (un po’ troppi, forse) e molte citazioni; e qualche interessante riflessione sull’accompagnamento spirituale: «L’eccessiva preoccupazione di sé non è indice di un cammino interiore ma può essere la manifestazione penosa e non riconosciuta del proprio narcisismo. Il direttore spirituale deve portare la persona guidata a specchiarsi in Cristo e non nel torbido dell’ego». Non sono d’accordo, ma questo non c’entra. Ernesto Buonaiuti, Francesco d’Assisi, Bietti 1939. La libertà del dilettante consente di non rinunciare a leggere libri che pure non rientrano nel novero degli «studi più recenti» o delle «ricerche più accreditate». Come nel caso di questo piccolo testo che cent’anni fa il grande Ernesto Buonaiuti ha approntato su san Francesco, nell’ambito della collana «Profili» (dapprima Formiggini, poi Bietti), una serie di «graziosi volumetti… tutti opera di autori di singolare competenza», intesi a offrire «vivaci, sintetiche e suggestive rievocazioni di figure attraenti e significative». Proprio così. Tra le righe di questo ritratto – scritte in un italiano che da solo vale la lettura – ci s’imbatte poi in osservazioni che vanno oltre la figura dello joculator Domini, il «giullare di Dio», quasi simbolo incarnato della vena più autentica e rivoluzionario-contraddittoria del cristianesimo; e d’altra parte «la società nominalmente cristiana ha sempre vissuto, nel suo secolare sviluppo, di una paradossale legge di contradizioni vicendevolmente compensatrici» (il corsivo è mio). La «minoranza infinitesimale» di Francesco (concetto che riassume splendidamente molte cose: l’esiguità del nucleo originale e il bisogno di «minorità», nonché l’attenzione all’assolutamente piccolo) trova la sua strada nel mondo delle «transazioni ufficiali» in forza di una superiore necessità, tanto che quando papa Innocenzo III diede la sua «approvazione provvisoria» alla nuova forma di vita «non ebbe davvero coscienza di aver autorizzato il più superbo tentativo di rinnovamento della prima vita evangelica, che da tredici secoli la società cristiana si fosse permesso». Inquadrato nelle visioni di Gioacchino da Fiore, il Francesco di Buonaiuti è un uomo solo, ma straniero a nessuno, amato oltre misura da un piccolo gruppo di testimoni diretti per la sua «semplicità irriflessa», il suo «entusiasmo di primitivo», il suo essere allo stesso tempo, perfettamente e lietamente, dentro il mondo e fuori di esso, come nessun altro mai dopo Gesù. L’immagine, suggerita da Buoniauti, che mi porterò dietro è questa, relativa al ritiro in solitudine sul monte Subasio: «Si diede a ramingare, solitario, nella campagna, addestrandosi al misterioso linguaggio delle creature minuscole o imponenti, esili o maestose, fragile ed effimere o resistenti ed eterne che popolano la natura disabitata dagli uomini, e che noi, nella nostra egocentrica angustia mentale e nella nostra inguaribile pigrizia psichica, definiamo inanimate o inintelligenti solo perché ci siamo sequestrati dal loro consorzio e ci siamo serrati alla loro ineffabile e suggestiva parola».
Ernesto Buonaiuti, Francesco d’Assisi, Bietti 1939. La libertà del dilettante consente di non rinunciare a leggere libri che pure non rientrano nel novero degli «studi più recenti» o delle «ricerche più accreditate». Come nel caso di questo piccolo testo che cent’anni fa il grande Ernesto Buonaiuti ha approntato su san Francesco, nell’ambito della collana «Profili» (dapprima Formiggini, poi Bietti), una serie di «graziosi volumetti… tutti opera di autori di singolare competenza», intesi a offrire «vivaci, sintetiche e suggestive rievocazioni di figure attraenti e significative». Proprio così. Tra le righe di questo ritratto – scritte in un italiano che da solo vale la lettura – ci s’imbatte poi in osservazioni che vanno oltre la figura dello joculator Domini, il «giullare di Dio», quasi simbolo incarnato della vena più autentica e rivoluzionario-contraddittoria del cristianesimo; e d’altra parte «la società nominalmente cristiana ha sempre vissuto, nel suo secolare sviluppo, di una paradossale legge di contradizioni vicendevolmente compensatrici» (il corsivo è mio). La «minoranza infinitesimale» di Francesco (concetto che riassume splendidamente molte cose: l’esiguità del nucleo originale e il bisogno di «minorità», nonché l’attenzione all’assolutamente piccolo) trova la sua strada nel mondo delle «transazioni ufficiali» in forza di una superiore necessità, tanto che quando papa Innocenzo III diede la sua «approvazione provvisoria» alla nuova forma di vita «non ebbe davvero coscienza di aver autorizzato il più superbo tentativo di rinnovamento della prima vita evangelica, che da tredici secoli la società cristiana si fosse permesso». Inquadrato nelle visioni di Gioacchino da Fiore, il Francesco di Buonaiuti è un uomo solo, ma straniero a nessuno, amato oltre misura da un piccolo gruppo di testimoni diretti per la sua «semplicità irriflessa», il suo «entusiasmo di primitivo», il suo essere allo stesso tempo, perfettamente e lietamente, dentro il mondo e fuori di esso, come nessun altro mai dopo Gesù. L’immagine, suggerita da Buoniauti, che mi porterò dietro è questa, relativa al ritiro in solitudine sul monte Subasio: «Si diede a ramingare, solitario, nella campagna, addestrandosi al misterioso linguaggio delle creature minuscole o imponenti, esili o maestose, fragile ed effimere o resistenti ed eterne che popolano la natura disabitata dagli uomini, e che noi, nella nostra egocentrica angustia mentale e nella nostra inguaribile pigrizia psichica, definiamo inanimate o inintelligenti solo perché ci siamo sequestrati dal loro consorzio e ci siamo serrati alla loro ineffabile e suggestiva parola». Come potevo resistere davanti a un titolo del genere, che unisce tre centri di interesse sempre rinnovato: Medioevo monastico, nello specchio dei libri. Il corposo e ambizioso – a detta della stessa autrice – libro di Lidia Buono1 mira a «tracciare i percorsi attraverso cui l’ingente patrimonio culturale dell’antichità ha alimentato l’universo intellettuale del Medioevo», nella specifica declinazione monastica e ponendo al centro del discorso il libro «come medium della sacra scrittura e, in tal senso, spazio letterario e strumento d’elezione in cui si realizza l’incontro tra l’uomo e l’alterità divina». (E già qui, volendo, sarebbe bello poter decidere se anche oggi gli oggetti chiamati libri possono essere ancora luogo di incontro con una qualsivoglia alterità.)
Come potevo resistere davanti a un titolo del genere, che unisce tre centri di interesse sempre rinnovato: Medioevo monastico, nello specchio dei libri. Il corposo e ambizioso – a detta della stessa autrice – libro di Lidia Buono1 mira a «tracciare i percorsi attraverso cui l’ingente patrimonio culturale dell’antichità ha alimentato l’universo intellettuale del Medioevo», nella specifica declinazione monastica e ponendo al centro del discorso il libro «come medium della sacra scrittura e, in tal senso, spazio letterario e strumento d’elezione in cui si realizza l’incontro tra l’uomo e l’alterità divina». (E già qui, volendo, sarebbe bello poter decidere se anche oggi gli oggetti chiamati libri possono essere ancora luogo di incontro con una qualsivoglia alterità.) «Costoro, abbandonato il suolo terrestre, che tutti, senza eccezione, calpestiamo, in quanto dimora poco spirituale, e rifiutatisi di vivere sulla terra, si innalzarono, con tutto loro stessi, su colonne turrite o su pilastri elevati a un’altezza vertiginosa, vi piantarono il loro nido come uccelli amanti della quiete, e risiedettero a mezz’aria, senza tetto e senza suppellettili, a guisa di volatili, e praticando, nel corpo, una condotta di vita pari a quella degli angeli, e seguendo un comportamento al di là dell’umano, trascorsero moltissimi anni in modo soprannaturale». Così riassume perfettamente e introduce il suo argomento l’anonimo autore della Vita di san Luca stilita, citato da Laura Franco nel suo ottimo Al di sopra del mondo, ampia ricognizione del per certi versi misterioso fenomeno degli stiliti1.
«Costoro, abbandonato il suolo terrestre, che tutti, senza eccezione, calpestiamo, in quanto dimora poco spirituale, e rifiutatisi di vivere sulla terra, si innalzarono, con tutto loro stessi, su colonne turrite o su pilastri elevati a un’altezza vertiginosa, vi piantarono il loro nido come uccelli amanti della quiete, e risiedettero a mezz’aria, senza tetto e senza suppellettili, a guisa di volatili, e praticando, nel corpo, una condotta di vita pari a quella degli angeli, e seguendo un comportamento al di là dell’umano, trascorsero moltissimi anni in modo soprannaturale». Così riassume perfettamente e introduce il suo argomento l’anonimo autore della Vita di san Luca stilita, citato da Laura Franco nel suo ottimo Al di sopra del mondo, ampia ricognizione del per certi versi misterioso fenomeno degli stiliti1. (la prima parte è
(la prima parte è  Nonostante siano passati quasi cinquant’anni dalla sua pubblicazione, o forse proprio per questo motivo, il libro che Georges Duby ha dedicato all’arte cistercense (e a san Bernardo) si legge con grande piacere, e direi anche con grande profitto1. Il piacere è dovuto in gran parte al testo vero e proprio, steso in uno stile storiografico sempre meno frequentato che non rinuncia, in nome della precisione e del rigore, a un evidente impulso narrativo, sfrondato dagli apparati, che lo rende «appassionante»; mentre il profitto deriva dal fatto che la lettura di Duby del fenomeno artistico cistercense, eminentemente architettonico, potrà anche essere datata e da aggiornare (io però non lo so), ma non può essere di certo del tutto fuori fuoco.
Nonostante siano passati quasi cinquant’anni dalla sua pubblicazione, o forse proprio per questo motivo, il libro che Georges Duby ha dedicato all’arte cistercense (e a san Bernardo) si legge con grande piacere, e direi anche con grande profitto1. Il piacere è dovuto in gran parte al testo vero e proprio, steso in uno stile storiografico sempre meno frequentato che non rinuncia, in nome della precisione e del rigore, a un evidente impulso narrativo, sfrondato dagli apparati, che lo rende «appassionante»; mentre il profitto deriva dal fatto che la lettura di Duby del fenomeno artistico cistercense, eminentemente architettonico, potrà anche essere datata e da aggiornare (io però non lo so), ma non può essere di certo del tutto fuori fuoco.