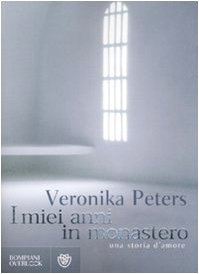Giovanni Cassiano affronta l’argomento intorno al 420, nelle Istituzioni cenobitiche (IV, 30 e segg.), e lo fa dapprima raccontando la storia dell’abate Pinufio, poi riportando le sue parole. L’argomento è l’ammissione di un novizio al monastero. Siamo in quel periodo di enorme interesse in cui la Regola si sta cristallizzando, in cui mille consuetudini provate sul campo stanno per trasformarsi in una norma prevalente. Rivolgendosi a un giovane, Pinufio dice: «Tu ti sei reso conto di quanti giorni sei rimasto alla porta del monastero per essere oggi ricevuto. Ed ora devi renderti ragione di questa tua attesa». Pinufio, da parte sua, aveva atteso «per un periodo abbastanza lungo» fuori del monastero di Tabennesi, poi aveva passato tre anni al servizio del fratello giardiniere, mentre gli altri monaci si domandavano se lui fosse adatto alla loro forma di vita.
Poco più di un secolo dopo Benedetto sistema la cosa con indicazioni precise. Nel capitolo 58 della Regola colui che bussa alla porta del monastero perché vuole farsi monaco aspetterà fuori «quattro o cinque giorni», poi starà «pochi giorni» nella foresteria, quindi entrerà in noviziato. Qui farà esperienza della forma di vita e verrà istruito, dopo due mesi gli verrà letta la Regola, poi altri sei mesi di noviziato, altra lettura della Regola, altri quattro mesi e terza lettura della Regola. In capo a un anno, quindi, dopo aver riflettuto, provato e capito cosa lo aspetta, sarà accolto.
Passano i secoli e, com’è naturale, secondo alcuni, la regola si allenta. A Cluny pare che accolgano subito chi ne fa richiesta, senza seguire tutta la trafila. I cisterciensi, che si vogliono paladini del ritorno alla vera osservanza, puntano il dito contro i cluniacensi: «Voi non seguite la Regola», fate di testa vostra (ovviamente la vicenda è più sfumata). La polemica va affrontata prima che degeneri e Pietro il Venerabile, abate di Cluny, scrive a Bernardo, ricapitolando i punti della contesa (venti) e rispondendo alle accuse: è la lettera 28 dell’epistolario di Pietro, databile intorno al 1122-23.
È una lettera lunga e mirabile, one hundred percent the Venerable style. Okay, dice Pietro, «tralasciando per il momento quelle cose con le quali potremmo giustamente attaccarvi [gran maestro di tattica], risponderemo alle obiezioni che… ci avete rivolto», e al primo punto c’è proprio la questione dei novizi.
«Nell’accogliere i novizi osserviamo in maniera assoluta la Regola, poiché seguiamo quella parola che dice: Tutto ciò che il Padre mi dà verrà a me, e colui che viene a me non lo respingerò» (Gv 6, 37). La difesa di Pietro è molto interessante ed è basata su una mossa cruciale: osservare la Regola in maniera assoluta non significa osservarla in ogni suo «apice e iota», bensì seguire il Vangelo. La vita monastica non è forse una vita apostolica? E qual è il suo cuore? «Noi professiamo di seguire la regola della madre carità, che rivendica come cosa propria a se stessa il fatto che tutto ciò che avviene nella sua logica è chiarissimamente retto e non distorto, equo e non iniquo, giusto e non ingiusto»: la palla, per così dire, è ributtata in campo cisterciense. E inoltre: perché usare la durezza se con un po’ di condiscendenza possiamo salvare un’anima? Non è forse questo lo scopo di tutto? E ancora: colui che duramente respingessimo, potrebbe tornare nel mondo e perdersi, non è forse meglio evitarlo? E infine: «A tutto ciò aggiungiamo il fatto che in nome di questa considerazione della carità fraterna è lecito, soprattutto ai maestri della chiesa di Dio, trasgredire gli insegnamenti dei padri e, in vista dell’utilità delle anime, temperare i precetti delle diverse regole» – un’ammissione di grande rilievo.
Si noti che Pietro non nega mai i «fatti» di cui vengono accusati i cluniacensi, su questo come su tutti gli altri diciannove punti, tutta la sua difesa è incentrata sul distanziamento dalla lettera della Regola e su una visione più ampia, basata appunto sul comandamento della carità. Poiché tuttavia è intellettualmente onesto, cinquanta pagine dopo (sembra quasi che la sua tattica sia la presa per sfinimento) ammette: sì, voi potete comunque accusarci di trasgredire il voto che abbiamo fatto di osservare la Regola; è vero, i novizi, ad esempio, li accogliamo subito. Per rispondere, l’abate di Cluny si alza in piedi: «A ciò rispondiamo: anche se diceste ciò mille volte, noi mille volte vi risponderemmo: abbiamo fatto voto di osservare la Regola, ma non abbiamo escluso dalla Regola la carità. Se avessimo escluso la carità non si potrebbe dire che abbiamo fatto voto di osservare una regola, poiché se manca ciò che rende una regola retta non si dà più una regola». Vedete voi, commenta l’abate di Cluny con una stoccata da maestro, «o con la rettitudine seguite la regola o, senza rettitudine, seguite la deviazione. Cioè, è inevitabile che o con la carità siate in possesso della Regola, o senza carità teniate in mano del fumo».
Pietro il Venerabile, Lettera 28, in Sotto la guida del Vangelo. Cluny e Cîteaux: testi e storia di una controversia, a cura di Cecilia Falchini, Edizioni Qiqajon 2013, pp. 101-183 (l’episodio precedente della “serie” è qui.)