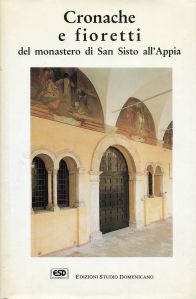 (la prima parte è qui)
(la prima parte è qui)
«Il cammino delle monache, riunite a San Sisto dal fondatore San Domenico di Guzman [nel 1221], è stato lungo nel tempo: tra due decenni il monastero celebrerà gli otto secoli di vita; ma, com’era nell’ordine delle cose, non le ha portate molto lontano nello spazio: dall’Appia a Magnanapoli [attuale sede dell’Angelicum, la Pontificia università S. Tommaso d’Aquino], a Montemario, pochi chilometri in linea d’aria, sempre nell’ambito di Roma, della quale le monache di San Sisto e poi dei Santi Domenico e Sisto erano fiere di essere figlie.» Questo l’epilogo, datato 1993 del fluviale volume di Cronache e fioretti che il domenicano Raimondo Spiazzi ha ricavato, dome si diceva, dai dodici volumi manoscritti conservati nel monastero di Santa Maria del Rosario a Montemario, attuale sede della comunità1.
È raro poter leggere un libro, non di ricostruzione storiografica, che restituisca con tale evidenza quel senso del tempo, di continuità nel tempo, che rappresenta per me uno degli aspetti cruciali dell’interesse per le «cose monastiche». Ci si trova, infatti, per fare un solo esempio, di fronte alla medesima comunità di suore che, a loro modo, registrano sconvolte i fatti del Sacco di Roma del maggio 1527 e, altrettanto sconvolte, i fatti del rapimento e poi dell’assassinio del «Presidente del partito “Democrazia Cristiana”» Aldo Moro del maggio 1979. Le monache sono ovviamente diverse, figlie dei loro rispettivi tempi e di differenti provenienze e formazioni (questo il senso di a loro modo), ma la comunità è la stessa.
Sono sicuro, ahimè, che dimenticherò molte delle cose che ho letto, soprattutto gli echi che nelle cronache suscitano fatti storici altrimenti noti: la «cattività avignonese», un soggiorno della figlia di Alessandro VI Borgia («Appena Lucrezia entrò, in quelle mura dove prima si respirava solitudine, silenzio, raccoglimento, si vide prodursi un’agitazione continua, un tumulto, una dissipazione che è più facile immaginare che descrivere»), la morte del Savonarola, il Sacco del 1527 («Non un solo crocifisso presente nelle chiese ricevette meno di cento, duecento colpi di pugnale, di spada o di lancia»), il pontificato di Pio V Ghislieri (artefice del primo trasferimento della comunità nel 1575, 356 anni dopo la fondazione), i francesi a Roma nel 1798, la Restaurazione e infine l’Unità d’Italia e le sue conseguenze («Nel giorno 9 settembre 1871, d’infausta memoria, il nuovo Governo d’Italia s’impossessava del monastero domenicano dei SS. Domenico e Sisto che veniva destinato ad uso di uffici governativi»), il pontificato di Pio XII Pacelli (artefice del secondo trasferimento della comunità nel 1931, anche in questo caso 356 anni dopo il primo: «Per provvidenziale disposizione del Cielo il Capo del Governo, Benito Mussolini, si mostrò favorevole»), la guerra, i bombardamenti, la Liberazione, le elezioni del giugno 1946 («Grazie a Dio il nostro popolo s’è affermato, con grandissima maggioranza, sui partiti sovversivi»), l’attentato a Giovanni Paolo II del maggio 1981 («Nella nostra Comunità si ha la facoltà, per questa circostanza, di seguire qualche programma televisivo»)…
Non dimenticherò invece, spero, l’immagine delle centinaia e centinaia di consorelle che sfilano in queste pagine, tutte confuse in un’unica schiera, tutte con un loro piccolo o grande tratto individuale, per quanto le carte e il tempo abbiano consentito di conservarne testimonianza: quella più ammirabile che imitabile, quella che non volle più sapere nulla del mondo e nemmeno vedere troppo spesso i suoi genitori, quella che per dormire non si tolse mai la tunica, l’abito e lo scapolare, i due veli, la cintura, le calze e le pantofole, quella nemica delle ciancie, sterminatrice delle mormorazioni, anche lievi, quella la cui vita di religione fu così lunga che per indicare la lunga esistenza di una cosa o di una persona, nel monastero si suol dire proverbialmente: «Ha l’antichità di suor Filippa», quella (m. Costanza Alli) che, morta a 102 anni («di cui ottanta trascorsi in religione») attraversò tutto il 1500, quella che era di alta statura, di complessione robusta e forte, di tinta rossastra, quella che era di carnagione bianca, di statura alta e piena di vita, quella che aveva la lingua ingombrata, sicché le era difficile pronunciare tutte le parole, quella che come condimento cospargeva i cibi di cenere, quella che conosceva perfettamente la lingua greca, quella che era soggetta a scrupoli, quella che era di maniere un po’ brusche, ma nel fondo era molto affabile…
So che la mia fascinazione è legata alle parole, e quindi in un certo senso è superficiale, ma il ricordo di queste donne, dei loro gesti, paure, devozioni, gioie, vite – come di ogni altra cosa in fondo – alle parole è affidato, quindi non la reprimo e lascio che le immagini scorrano, fino all’ultima: il 16 novembre 1981 papa Giovanni Paolo II visita il monastero a conclusione di una visita pastorale a Montemario e «all’impressione di repentinità con cui tutto si era svolto», commentano le monache, «al rammarico di aver ricevuto Sua Santità forse stanco, quando già da alcune ore era in visita alla parrocchia di Santa Maria “Stella Mattutina”, si è sostituito un diverso sentimento: è stato forse meglio così, che la giornata pastorale [del papa] si concludesse qui, nel silenzio di un monastero claustrale. Tutto questo sarà anche, senza dubbio, l’argomento gioioso delle nostre ricreazioni per chissà quanto tempo ancora».
(2-fine)
______
- Cronache e fioretti del monastero di San Sisto all’Appia, a cura di p. Raimondo Spiazzi, o.p., Edizioni Studio Domenicano 1993.

