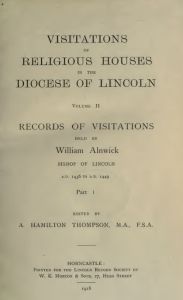 (la prima parte è qui)
(la prima parte è qui)
Continua il verbale della visita del vescovo di Lincoln al priorato di Catesby (17 luglio 1442).
Suor Agnes Allesley afferma che la priora semina discordia tra le suore, dicendo: «Così e così ha parlato una di voi», se colei a cui si rivolge ha trasgredito in qualche modo. Afferma inoltre quanto sopra riguardo allo scandalo della priora e di Sir William Taylour, che ora risiede a Boughton, vicino a Northampton; e afferma che l’eccessiva gentilezza tra loro è stata causa di scandalo, perché alla mattina usciva per andare ai laboratori da sola con quel cappellano; e quando la priora è stata informata di tale scandalo, quel cappellano, dopo la sua partenza, è venuto alla casa tre volte in un mese. Le rendite della casa, tredici anni prima, valevano sessanta sterline all’anno e ora a malapena cinquanta; e questa diminuzione è dovuta al cattivo governo della priora e di sir William Taylour, e alla negligenza nella riparazione delle case e nell’acquisto di tenutari, ecc. Inoltre, due ovili sono rimasti senza tetto negli ultimi due anni: quindi il legno sta iniziando a marcire e gli agnelli che vi crescevano sono morti a causa dell’umidità. Dice inoltre che al momento dell’ingresso della priora la casa era poco o per niente indebitata. Allo stesso tempo ha trovato anche tovaglie adatte a servire il re e un set di dodici cucchiai d’argento; e ora tutto è scomparso, e i cucchiai e gli altri utensili che si trovano nella casa appartengono alla madre della priora. Dice inoltre che il coro non viene osservato, poiché la priora chiama le giovani suore per svolgere suoi affari.
Suor Alice Kempe afferma che, poiché le suore durante l’ultima visita rivelarono ciò che doveva essere rivelato, la priora ne ha frustate alcune; e che la priora è troppo crudele e dura con le suore e non le ama. Inoltre, se per caso le suore trasgrediscono, le rimprovera, e lo fa davanti ai laici, e persino durante l’ufficio divino, senza esitare. Inoltre, la priora svela i segreti della loro religione ai laici.
Suor Agnes Halewey afferma che la priora, sia in coro che fuori, strappa i veli dalla testa delle suore, chiamandole mendicanti e prostitute. Inoltre, sebbene sia giovane e desiderosa di imparare la disciplina religiosa e altre cose, la priora la incarica di rifare i letti, cucire, filare e altri compiti. Dice anche che…
E la priora cosa dice?
La priora nega l’accusa di crudeltà per quanto riguarda il chiamarle prostitute e mendicanti; nega anche l’uso violento delle mani con le monache. Quanto al non aver reso conto, lo confessa, e lo fa perché non ha un segretario in grado di scrivere. Quanto al peso del debito, rimanda al resoconto che verrà fatto ora. Quanto alla negligenza nel riparare gli ovili, rimanda alle prove visibili. Quanto al calice impegnato, afferma che è stato fatto con il consenso del convento per il pagamento delle decime. Quanto all’abbattimento degli alberi, afferma che è stato fatto a vantaggio della casa, in parte con la consapevolezza e in parte all’insaputa del convento. Quanto alle rivelazioni durante l’ultima visita e ai rimproveri a coloro che le hanno fatte e alle frustate, nega l’accusa. Quanto alle minacce affinché le suore non rivelassero nulla, nega l’accusa. Quanto alla divulgazione dei segreti della loro religione, nega l’accusa. Quanto a sua madre e a Joan Coleworthe, nega l’accusa. Quanto al rifare i letti e ad altri lavori, nega l’accusa. Quanto al negare cibo e vestiario alle suore, lo confessa in parte. Quanto al degrado degli edifici esterni, afferma che sono in parte in riparazione e in parte no. Quanto al seminare discordia, afferma che potrebbe averlo fatto, ma non ne è certa. Quanto al fatto che abbia affermato di essere venuta a conoscenza di tutte le rivelazioni dell’ultima visita in cambio di una borsa e del denaro, nega categoricamente l’accusa. Quanto a sir William Taylour, nega il crimine in qualsiasi tempo.
La priora ha avuto il giorno successivo per scagionarsi [dalle accuse] che ha negato insieme a quattro delle sue sorelle, e per ricevere la penitenza per quelle che ha confessato. Al quale termine non ha presentato alcuna compensazione, e pertanto è stata dichiarata inadempiente e, non avendo presentato nulla, dichiarata colpevole; ha abiurato dal suddetto uomo e da ogni rapporto di familiarità con lui da allora in poi.
Isabel Benet confessa il suo crimine, ma non con Sir William Smythe. Ciò nonostante ha abiurato da lui e da ogni rapporto di familiarità [con lui] da allora in poi, e dovrà scontare la sua penitenza il giorno successivo. Dopodiché si è scagionata con Juliane Wolfe, Elizabeth Langley, Alice Holewelle e Alice Kempe.
Riguardo alle candele, la priora dice che saranno fornite. Riguardo ai cappellani, la priora dice che non se ne possono avere; farà tutto il possibile affinché ve ne siano.
Quindi [il signor vescovo] ha rinviato la sua visita al giorno dopo, essendo presenti Depyng, Thorpe e io, Colstone. Il signor vescovo ha ordinato che ci fossero due [suore] ricevitrici, [per ricevere e pagare il denaro da conservare in una cassa] sotto tre serrature; e che tutte avessero un incarico comune, lasciando da parte le proprie famiglie, e che queste cose avessero inizio dal prossimo giorno di San Michele. E tutte sono state ammonite di allontanare tutti i secolari dal dormitorio il giorno dopo l’Assunzione. E tutte sono state ammonite, sotto pena di scomunica, che nessuna rimproverasse un’altra a causa delle sue rivelazioni. E la priora è stata ammonita di [chiudere] e aprire le porte della chiesa e del chiostro agli orari stabiliti, e di tenere le chiavi con sé durante la notte. Quindi ha rinviato la sua visita al martedì successivo, dopo la festa di Sant’Andrea, essendo presenti Depyng, Thorpe e io, Colstone.
(2-fine)
♦ Visitations of Religious Houses in the Diocese of Lincoln, vol. II: Records of Visitations Held by William Alnwick, Bishop of Lincoln (1436-1449), part I, edited by A. Hamilton Thompson, W. K. Morton & Sons 1918. A indirizzarmi all’esplorazione di questi fantastici verbali di visite vescovili è stata Eileen Power, con il suo Vita nel Medioevo (Einaudi 1966), in particolare con il capitolo dedicato alla badessa, M.me Englentyne.





