Nell’autunno del 1061 Pier Damiani è a Roma, impegnato a fianco del papa Alessandro II, ma trova il tempo per scrivere una lunga lettera (l’Opusculum LII delle sue Opere) agli amati monaci di Montecassino, guidati allora dall’abate Desiderio («arcangelo dei monaci»), che è «un vero e proprio bestiario moralizzato ad usum monachorum»1. A leggere queste pagine con occhiali moderni bisogna resistere alla tentazione del divertimento e anche a quella, tipicamente medioevale, del «meraviglioso» (cui pure l’«Avellanita» dedicherà altri scritti). Qui, infatti, il grande monaco eremita – e il grande scrittore – è mortalmente serio, perché ne va sempre e comunque della salvezza dell’anima e perché Dio ha disposto le cose «affinché, perfino per mezzo delle bestie, l’uomo sia in grado di apprendere ciò che deve imitare, ciò che tocca, a lui, di fuggire, ciò che può utilmente, da loro, prendere a prestito». È da notare anzitutto che Pier Damiani non si vanta di essere un esperto del mondo animale, ma che riporterà «solamente ciò che, da quanti con sudore hanno osservato le realtà della natura, è stato messo a nostra disposizione nel modo più certo e inconfutabile». L’inciso sottolineato è assai significativo, e Piero ribadirà più volte il concetto, ad esempio nel capitolo 15, parlando del pellicano («Come tramandano coloro che si diedero da fare per conoscere a fondo la varia natura degli animali»), suggerendo chiaramente, direi, come la conoscenza richieda attività sul campo e costi fatica. Che poi il fatto che il pellicano uccida i suoi piccoli (come Dio castiga la prole ingrata) non sia né certo né inconfutabile è un altro discorso.
Eh sì, di certo e inconfutabile, oggi, non c’è pressoché niente in queste pagine, in cui la stessa osservazione non è mai neutra, ma si basa su presupposti morali, in particolar modo di origine biblica. È difficile non rimanere affascinati (e forse non soltanto affascinati) dalla rete di citazioni, riferimenti, citazioni, analogie dispiegata dal testo: una rete che ricopre il mondo (in questo caso quello naturale) senza smagliature. Gli animali dunque si dividono senza esitazioni in esempi buoni, esempi cattivi, simboli di tragica inconsapevolezza o di realtà superiori cui ispirarsi per non perire in questo «covile del diavolo» che è il mondo.
Così, il leone è buono, perché dorme con gli occhi aperti, come dovrebbero fare i monaci; il riccio è figura del diavolo, perché entra nelle vigne all’epoca della vendemmia e, scuotendo i tralci, fa cadere i chicchi maturi («che hanno il turgore delle virtù spirituali»), li infilza sugli aculei e se li porta via; la volpe non ne parliamo nemmeno, e neanche il polipo, che si finge roccia per catturare gli ignari pesci che si avvicinano: «Che altro è il polipo, se non l’uomo malvagio e fraudolento, e perciò eretico?»; molto meglio la fenice, che risorge «come il nostro Salvatore»; bene l’upupa, l’aquila e la folaga, ancora meglio le api, che «sono immuni dal coito, così nel partorire non sono costrette a subire nessun guasto»; «livido e immondo» l’ibis, per non parlare della iena, bene invece la dorcade, «che latinamente chiamiamo “capriolo”, [e che] offre al nostro stile di vita il non inutile esempio della propria indole naturale»: sguardo acuto e capacità di discernimento; lo sguardo acuto è anche della lince, «non solo in grado di penetrare qualsiasi corpo solido, ma anche le pareti in pietra»: mettete un pezzo di carne dietro un muro e vedrete…; ottimo il serpente, che cerca una fenditura nella pietra (la penitenza) e si toglie di dosso la vecchia pelle (dei peccati), ottima la formica, che sa discernere i chicchi delle messi, supremo infine il castoro, che ha capito che gli si dà la caccia per le virtù terapeutiche dei suoi genitali, sicché, «quando si accorge che il cacciatore lo insegue… se li recide a morsi e li getta davanti al cacciatore», se poi capita un altro cacciatore, il castoro gli si alza di fronte mostrandogli «che gli manca ciò che per cui è così ambito», dunque «pure tu, se vuoi sfuggire al cacciatore che ti insidia nella più profonda intimità, studiati con ogni mezzo di troncare di netto da te i dilettosi eccitamenti del piacere». Ecc. ecc.
A un certo punto Pier Damiani si ricorda «che non a un libro, ma a una lettera abbiamo dato inizio» e che bisognerebbe concludere. Non ce la fa, ha ancora due o tre storie che muore dalla voglia di raccontare: il granchio e l’ostrica, la scimmia, la balena, e visto che di monaci parliamo, sapete come fa il granchio a catturare l’ostrica di cui è ghiotto? Come fa a papparsi il «cibo carneo» ben difeso dalle due valve «assai robuste» che scattano alla minima minaccia? Fa così: si apposta e quando l’ostrica si apre butta lì un sassolino, cosicché non possa più richiudersi, e allora «introduce le chele senza correre alcun rischio, e dall’ostrica estrae la parte più interna e riposta». La morale è ineccepibile: «A cosa sembra più convenientemente alludere l’ostrica, se non al monaco? Sicuramente questi vive finché lo circonda l’obbligo rigoroso del silenzio, al contrario perisce quando si apre per parlare senza moderazione». E che cos’è il sassolino se non la «pietruzza, per dir così, della cattiva abitudine»? Già, perché «di che altro è figura il granchio, la cui natura è di procedere a ritroso, se non dello spirito ribelle», cioè del diavolo?
______
- Pier Damiani, Lettera sul valore della vita religiosa e sulla interpretazione simbolica di numerosi animali (Opusc. LII), in Lettere ai monaci di Montecassino, a cura di A. Granata, Jaca Book 1988, pp. 103-142.

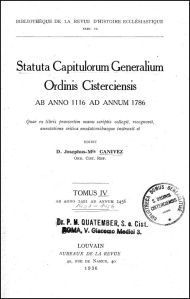

 A conclusione dell’ottimo volume delle Lettere ai monaci di Montecassino di Pier Damiani – ottimo soprattutto per la qualità della traduzione e dei lunghi cappelli introduttivi ai singoli testi – si legge la Lettera in lode della flagellazione e, come si suol dire, della disciplina1, breve testo violento e corrusco, sospinto, per usare un’espressione del curatore, «dal soffio della sua [di Pier Damiani] straripante ansia di mortificazione e di penitenza, anche corporale». Curatore, Aldo Granata, che spende non poche e assai rifinite pagine per «contestualizzare» (dal punto di vista storico, religioso e con un accenno anche alla psicoanalisi) una pratica, la flagellazione, e l’autoflagellazione nello specifico, «in altro modo difficilmente accessibile alla luce dell’odierne categorie mentali e del nostro concetto di religiosità».
A conclusione dell’ottimo volume delle Lettere ai monaci di Montecassino di Pier Damiani – ottimo soprattutto per la qualità della traduzione e dei lunghi cappelli introduttivi ai singoli testi – si legge la Lettera in lode della flagellazione e, come si suol dire, della disciplina1, breve testo violento e corrusco, sospinto, per usare un’espressione del curatore, «dal soffio della sua [di Pier Damiani] straripante ansia di mortificazione e di penitenza, anche corporale». Curatore, Aldo Granata, che spende non poche e assai rifinite pagine per «contestualizzare» (dal punto di vista storico, religioso e con un accenno anche alla psicoanalisi) una pratica, la flagellazione, e l’autoflagellazione nello specifico, «in altro modo difficilmente accessibile alla luce dell’odierne categorie mentali e del nostro concetto di religiosità».