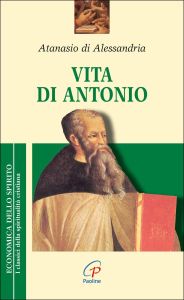 La cosiddetta «grande catechesi ai monaci» di Antonio occupa i capitoli 16-43 della di lui Vita scritta da Atanasio di Alessandria1. Sono parole spesso illuminanti, talvolta curiose, quasi sempre improntate a una grande praticità, sempre interessanti – per comodità diremo che sono parole pronunciate qualche anno dopo il 300 – e provengono da un cinquantenne che ha alle spalle più o meno trentacinque anni di eremitismo e ascesi, tanto che una delle prime cose che dice ai monaci che l’hanno sollecitato è che «io più anziano di voi vi affiderò quello che so e che ho imparato dall’esperienza».
La cosiddetta «grande catechesi ai monaci» di Antonio occupa i capitoli 16-43 della di lui Vita scritta da Atanasio di Alessandria1. Sono parole spesso illuminanti, talvolta curiose, quasi sempre improntate a una grande praticità, sempre interessanti – per comodità diremo che sono parole pronunciate qualche anno dopo il 300 – e provengono da un cinquantenne che ha alle spalle più o meno trentacinque anni di eremitismo e ascesi, tanto che una delle prime cose che dice ai monaci che l’hanno sollecitato è che «io più anziano di voi vi affiderò quello che so e che ho imparato dall’esperienza».
Anzitutto perseverate e non scoraggiatevi, e misurate il vostro sforzo ascetico del giorno all’eternità, le vostre rinunce terrene all’universo: «La terra intera è piccolissima a confronto di tutto il cielo»; abbandonate quindi i vostri beni senza remore, tanto se non è oggi (per virtù), sarà domani (per avvenuto decesso), no? Che poi «spesso accadrà di lasciarli a persone che non volevamo». Da questo punto di vista è assai utile, al mattino, pensare che non si arriverà a sera, e viceversa. Se vi mettete su questa via, state certi che arriveranno i demoni, dei quali «vi è grande varietà», e «si potrebbe parlare a lungo della loro natura e della loro diversità, ma un tal discorso si addice ad altri più grandi di noi. Quel che ora è necessario e indispensabile è soltanto conoscere gli espedienti che utilizzano contro di noi», cioè veniamo, appunto, agli aspetti pratici.
Essendo caduti dal cielo, il loro scopo primario è che non vi ascendiamo, quindi per prima cosa piazzano sul nostro cammino degli ostacoli, «gli ostacoli sono i pensieri impuri». Se resistiamo alle tentazioni, allora giocano la carta delle visioni mostruose, «imitando donne, belve, rettili, corpi giganteschi ed eserciti di nemici», cercando di spaventarci col fuoco perché è nel fuoco che sono dannati. Niente paura: tutto si dilegua davanti agli occhi di chi rimane saldo. Attenzione che possono presentarsi anche come confratelli e «fingono di parlare come uomini di fede per trarci in inganno», o magari ci svegliano dicendoci che è ora di pregare, o addirittura sono capaci di citare la Scrittura. Qualunque cosa ci dicano, anche se sembra buona, non è mai a fin di bene, «non fanno questo per amor di Dio o per amore della verità, ma per trascinare i semplici alla disperazione e affermare che l’ascesi è inutile» e indurci al disgusto della vita solitaria. Non dimenticate mai che in fondo sono impotenti («giocano come se fossero sul palcoscenico, mutano aspetto, spaventano i bambini… assumendo forme diverse»); che se lo fossero, potenti, «non verrebbero in molti, non ricorrerebbero a visioni, né muterebbero sembianze; sarebbe sufficiente che ne venisse uno solo e facesse tutto quello che può e vuole fare». E non allarmatevi se vi sembra che predicano il futuro: non sanno niente, tirano a indovinare, fanno congetture sulla base delle esperienze passate.
Una regoletta semplice: se un pensiero o una visione vi provoca turbamento, difficilmente non sarà opera dei demoni («l’irruzione e l’apparizione tumultuosa degli spiriti malvagi sono accompagnate da colpi, strepiti e grida come avviene quando passano dei ragazzi maleducati, o quando giungono i predoni. Subito l’anima è presa da timore e da turbamento…»); se invece induce letizia e conforto, allora tutto bene («la gioia e la buona disposizione dell’anima dimostrano la santità di colui che appare»).
Antonio conclude il suo discorso raccontando alcuni episodi della sua personale lotta contro i demoni, demoni che a me paiono, come si suol dire… modernissimi. Tanto che il consiglio finale del padre dei monaci suona più che attuale: «Quando appare una visione, non si ceda al panico, ma di qualunque genere essa sia, per prima cosa si domandi, pieni di coraggio: “Chi sei e da dove vieni?” […] Perché anche solo il domandare: “Chi sei e da dove vieni” è segno di animo rappacificato».
______
- Atanasio di Alessandria, Vita di Antonio, introduzione, traduzione e note di L. Cremaschi, Paoline 202310, pp. 101-131.









