
Urna di sant’Agostino; S. Pietro in Ciel d’Oro, Pavia (foto Potts)
Il diacono cartaginese Deograzia chiede, intorno al 405, e il vescovo Agostino risponde. Avrei bisogno di un consiglio su come trattare i «principianti» (i rudes) che mi chiedono di essere istruiti nella fede cristiana, sono pieno di dubbi… Eh, ti capisco Deograzia, eccome se ti capisco, esordisce Agostino, e gli scodella un vero e proprio manuale pratico1, conciso, brillante, ricco di esempi e che trasuda sapienza psicologica ed esperienza sul campo («dico queste cose per esperienza…», «ti sono testimone di me stesso…»2).
Al centro dell’interessantissimo trattatello, tra una prima parte dedicata agli aspetti generali della questione, al fine e al valore della catechesi, ai motivi «di chi viene con l’intenzione di diventare cristiano», ai tipi diversi di ascoltatore, e una parte conclusiva occupata interamente da un esempio concreto (poniamo che si presenti un cittadino medio, «probabilmente lo indottrinerei con questo discorso…» – versione lunga e breve), Agostino elenca e analizza i principali motivi di insoddisfazione di chi insegna (il catechista; il professore?). Già, perché anch’io, dice Agostino, «mi rattristo nel dover constatare che la mia lingua non è in grado di esprimere il mio cuore. [Vorrei] che tutto quel che capisco venga capito da chi mi ascolta e mi accorgo di non parlare in modo che ciò avvenga…»
Non sempre, tuttavia, questa insoddisfazione nasce da una nostra mancanza di conoscenza. Può capitare, anzitutto, che l’ascoltatore resti impassibile: capisce? Non capisce? Si sta annoiando? Si è distratto? È necessario allora chiedere perché sta zitto e non reagisce nemmeno «con un gesto qualsiasi del corpo», e quindi aggiustare il tiro «secondo la sua risposta». Se poi l’ascoltatore sbadiglia bisogna «risvegliare il suo animo dicendo qualcosa condito da onesta allegria» – piazzare una battuta, insomma. Ah, è bene anche accertarsi che non sia stanco di stare in piedi, non c’è niente di male nel parlare e ascoltare seduti. Se l’impassibilità persiste, «raccontiamo qualcosa di veramente inaspettato e fuori del previsto». Breve, però!
Anche noi potremmo essere distratti, ad esempio da un pensiero grave, e ci annoia di dover tornare su ciò che «ci è notissimo», oppure avevamo altro da fare quando ci hanno chiamato. Avevamo tutte predisposte «secondo il nostro criterio le cose da fare» ed è arrivato uno che vuole sapere, domanda, insiste («Vieni a parlare con questo, vuole diventare cristiano», inciso di mirabile realismo). In tal caso, invece di seccarci, dobbiamo rallegrarcene, perché a Dio è piaciuto ordinare le cose secondo il Suo, di criterio.
Può capitare che ci manchino le parole, proprio quelle che ci parevano perfette quando leggevamo o ascoltavamo a nostra volta, e com’è che adesso non riusciamo a farci capire…? Né si può negare che possiamo essere stufi di ripetere sempre le stesse cose: ci salvi in questi casi l’amore fraterno: «Non accade forse di solito che quando mostriamo a chi non li ha mai visti prima luoghi belli ed ameni, di città o di campagna, che noi, avendoli già visti, attraversiamo senza alcun interesse, si rinnovi il nostro piacere nel loro piacere della novità? E tanto più, quanto sono amici!»
La carità verso i fratelli è sempre la motivazione dell’insegnamento e il rimedio per le insoddisfazioni e i problemi che possono sorgere: se questo è il fine di ogni discorso, «narra ogni cosa in modo che la persona a cui parli creda ascoltando, speri credendo ed ami sperando».
______
- Agostino d’Ippona, La catechesi ai principianti (De catechizandis rudibus), introduzione, traduzione e note di A.M. Velli, Paoline 20234.
- «Ti sono testimone di me stesso che, ora in un modo, ora in un altro, mi sento condizionato quando vedo davanti a me da catechizzare un erudito, un ignorante, un cittadino, un pellegrino, un ricco, un povero, un privato, un personaggio degno d’onore con assegnata qualche carica, un uomo di questa o quella gente, di questa o quella età o sesso, di questa o quella setta, reduce da questo o quel peccato…» (Che bella, tra l’altro, la nozione di essere reduci da un peccato.)

 All’interno del volume antologico La vita spirituale di André Louf1, monaco trappista, abate e luminoso scrittore di cose, appunto, spirituali, ci sono tre saggi dedicati specificatamente alla vita in comunione, saggi che, come dice Enzo Bianchi nella prefazione, oltre a trarre valore da una lunghissima esperienza di abbaziato (35 anni presso l’abbazia di Mont des Cats nella Francia del Nord), contengono «elementi di sapienza in cui anche chi si professa non credente potrà trovare spunti a cui attingere per una vita sensata, unificata, riconciliata».
All’interno del volume antologico La vita spirituale di André Louf1, monaco trappista, abate e luminoso scrittore di cose, appunto, spirituali, ci sono tre saggi dedicati specificatamente alla vita in comunione, saggi che, come dice Enzo Bianchi nella prefazione, oltre a trarre valore da una lunghissima esperienza di abbaziato (35 anni presso l’abbazia di Mont des Cats nella Francia del Nord), contengono «elementi di sapienza in cui anche chi si professa non credente potrà trovare spunti a cui attingere per una vita sensata, unificata, riconciliata». Capitolo IV. I controllori
Capitolo IV. I controllori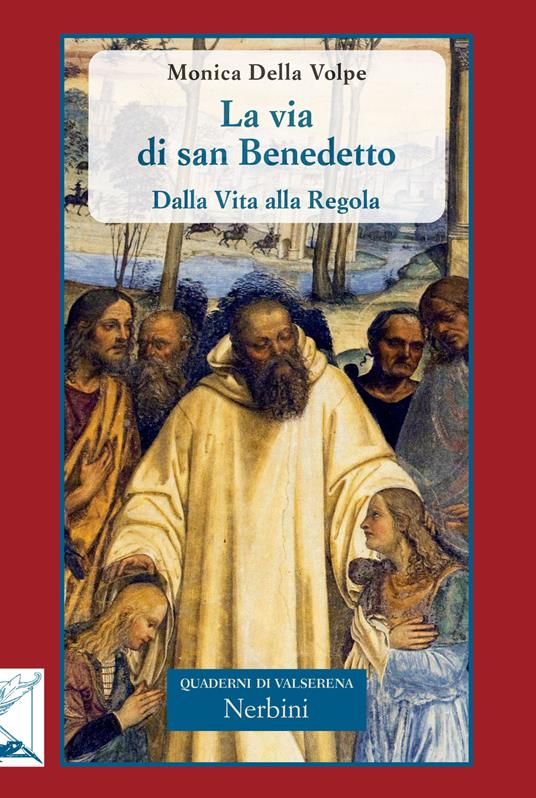 La via di Benedetto di Monica Della Volpe1 è un testo nato da una viva esperienza di lectio all’interno della comunità del monastero trappista di Valserena («Non sono considerazioni astratte: tale è stata la nostra esperienza, riflettendo sulla quale abbiamo raccolto queste considerazioni, e abbiamo meglio capito l’esperienza stessa»), cioè, si potrebbe dire, di «interrogazione» della Regola, letta in parallelo con la Vita di Benedetto di Gregorio Magno, con l’intenzione di evidenziare la diretta dipendenza di quello che, in fondo, è un «testo giuridico» dalla biografia di chi l’ha scritto: «È evidente che san Gregorio ha compreso il valore della via benedettina per l’uomo del suo tempo, e lo ha spiegato, secondo uno stile di racconto sapienziale allora chiarissimo per il cristiano comune, oggi più difficile da interpretare».
La via di Benedetto di Monica Della Volpe1 è un testo nato da una viva esperienza di lectio all’interno della comunità del monastero trappista di Valserena («Non sono considerazioni astratte: tale è stata la nostra esperienza, riflettendo sulla quale abbiamo raccolto queste considerazioni, e abbiamo meglio capito l’esperienza stessa»), cioè, si potrebbe dire, di «interrogazione» della Regola, letta in parallelo con la Vita di Benedetto di Gregorio Magno, con l’intenzione di evidenziare la diretta dipendenza di quello che, in fondo, è un «testo giuridico» dalla biografia di chi l’ha scritto: «È evidente che san Gregorio ha compreso il valore della via benedettina per l’uomo del suo tempo, e lo ha spiegato, secondo uno stile di racconto sapienziale allora chiarissimo per il cristiano comune, oggi più difficile da interpretare».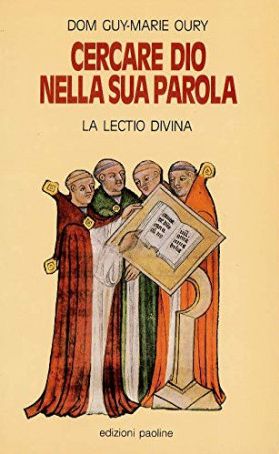 «Ogni relazione con Dio si basa su un diligente ascolto», afferma il benedettino Guy-Marie Oury (1929-2000, professo a Solesmes) nella prima pagina del suo libro sulla lectio divina1, ed è anzitutto nella Sacra Scrittura «che si può incontrare meglio Dio e ciò che egli ha detto di se stesso».
«Ogni relazione con Dio si basa su un diligente ascolto», afferma il benedettino Guy-Marie Oury (1929-2000, professo a Solesmes) nella prima pagina del suo libro sulla lectio divina1, ed è anzitutto nella Sacra Scrittura «che si può incontrare meglio Dio e ciò che egli ha detto di se stesso».