 Dal punto di vista economico, l’Ordine cistercense rappresenta, nella pratica di quella che tocca chiamare «gestione quotidiana», un momento di rottura rispetto alla società feudale: conduzione diretta della proprietà fondiaria, ricorso al lavoro salariato, rifiuto delle decime e allineamento al movimento di autonomia comunale; mentre dal punto di vista istituzionale il documento fondativo dell’Ordine, la Charta Charitatis (la cui messa a punto copre un arco di tempo che va dal 1119 al 1165), rappresenta «la prima carta costituzionale europea di democrazia a partecipazione diretta», «un originalissimo organismo giuridico escogitato con l’intento di salvaguardare l’autonomia delle singole abbazie e, nello stesso tempo, di conservare l’unità dell’Ordine e l’uniformità della vita monastica».
Dal punto di vista economico, l’Ordine cistercense rappresenta, nella pratica di quella che tocca chiamare «gestione quotidiana», un momento di rottura rispetto alla società feudale: conduzione diretta della proprietà fondiaria, ricorso al lavoro salariato, rifiuto delle decime e allineamento al movimento di autonomia comunale; mentre dal punto di vista istituzionale il documento fondativo dell’Ordine, la Charta Charitatis (la cui messa a punto copre un arco di tempo che va dal 1119 al 1165), rappresenta «la prima carta costituzionale europea di democrazia a partecipazione diretta», «un originalissimo organismo giuridico escogitato con l’intento di salvaguardare l’autonomia delle singole abbazie e, nello stesso tempo, di conservare l’unità dell’Ordine e l’uniformità della vita monastica».
Per conoscere un po’ più in dettaglio questi ed altri aspetti organizzativi, che, va ricordato, hanno la loro origine oltre che nello «spirito dei tempi», in una rinnovata volontà di adesione al dettato della Regola benedettina e soprattutto a quello del Nuovo Testamento, mi è stato di grande utilità il volume, ancorché di non facilissima reperibilità, di Federico Farina e Igino Vona1. Dopo aver riprodotto e commentato i due documenti fondamentali dell’Ordine, l’Exordium Parvum e, appunto, la Carta di Carità, i due studiosi ricostruiscono il concreto sviluppo della vita per così dire sociale dei Cistercensi facendo perno sui «due pilastri dell’organizzazione dell’Ordine», cioè la visita canonica dell’abate-padre alla casa-figlia, cioè la visita che l’abate di un’abbazia faceva regolarmente a tutti i monasteri che da quell’abbazia erano derivati per «filiazione», e sul Capitolo generale, cioè l’assemblea annuale degli abati di tutti i monasteri affiliati all’Ordine che si teneva a Cîteaux, il Novum monasterium, la culla dell’Ordine: con tutta evidenza i due studiosi, infatti, hanno esplorato minuziosamente gli immensi volumi degli Statuta Capitulorum Generalium Ordinis Cisterciensis ab anno 1116 ad annum 1786, in cui sono raccolti e consegnati ai fortunati e interessati posteri i verbali e le decisioni di quelle assemblee…
Non posso, e non è molto intelligente, cercare di riassumere qui in poche righe ciò che è stato esposto con ordine e ampiezza di citazioni, ma vorrei almeno esprimere il senso di meraviglia che suscitano queste nozioni. Penso anzitutto alle dimensioni di quell’assemblea, ai numeri (ricordando che «il numero delle fondazioni cistercensi resta una caso unico nella storia»): «Gli abati [seduti in ordine cronologico di fondazione] che nel 1116 erano quattro [oltre a Cîteaux, La Ferté, Pontigny, Clairvaux e Morimond], salirono a dodici nel 1120, a quaranta nel 1130, a trecento nel 1150, con un crescendo sempre maggiore fino a sfiorare il migliaio nel periodo aureo della storia dell’Ordine» – e vogliamo pensare ai «problemi logistici» di tali consessi2… Penso ai viaggi che tale impostazione comportava, una ininterrotta circolazione continentale di persone che coprivano distanze ragguardevoli (gli abati più lontani potevano partecipare con scadenze diverse, fino a una volta ogni sette anni per gli abati di Palestina, Siria e Cipro), affrontando talvolta inconvenienti non piccoli e di cui c’è traccia nei verbali. E poi le conversazioni, di persone che parlavano la stessa lingua e che in quella lingua di certo discutevano di «cose divine»3, ma si scambiavano anche notizie e informazioni su come far «funzionare le cose»: noi abbiamo usato questa pianta, noi per cucire facciamo così, noialtri in cucina abbiamo adottato questo e quest’altro, le mele le conserviamo così, abbiamo scoperto che, il nostro maestro dei novizi procede in questo modo, ecc. ecc. O quando ad esempio un’abbazia ne fondava un’altra i monaci che si trasferivano nel nuovo sito si portavano dietro, oltre a regole e consuetudini, magari anche qualche pianticella, qualche seme o vitigno.4 Penso ancora all’espressione rituale con la quale si dava inizio al Capitolo: «Loquamur de Ordine nostro», parliamo del nostro Ordine, parliamo di noi, frase che peraltro era d’uso nei capitoli quotidiani delle singole abbazie e dalla quale traspare quella riservatezza e quel vago orgoglio di appartenere a qualcosa di nuovo di cui furono accusati.
Certo, molte, moltissime deliberazioni riguardano dispute e controversie, complicazioni in caso di rinunce, elezioni contestate, denunce e dimissioni, precedenze, diritti acquisiti, prerogative, antagonismi tra abbazie5, faccende tributarie, e così via. Quante volte la questione è introdotta da: «Il Capitolo generale è venuto a conoscenza che…» E lo stesso Capitolo vedrà ridursi il proprio potere e crescere ovunque problemi di ogni genere, e dopo verrà la decadenza. Dopo.
Ma come non guardare ancora oggi con estremo interesse a quello slancio iniziale, collettivo e unitario al tempo stesso? A quella singolare forma di «Prima Internazionale», a quella «presenza intessuta a tela di ragno», che fa dire ai due studiosi: «Senza peccare di irriverenza pensiamo che alla mirabile sintesi teologica ubi Petrus ibi Ecclesia, si possa aggiungere, in retrospettiva storica per la durata di oltre un secolo: ubi Ecclesia ibi Cistercium».
______
- Federico Farina e Igino Vona, L’organizzazione dei Cistercensi nell’epoca feudale, prefazione di G. Andreotti, Edizioni Casamari 1988.
- «Una precisa e minuziosa prescrizione regolava il tempo di entrata nel monastero di Cîteaux, di permanenza (da due a cinque giorni), di partenza, prevedeva per ciascun abate un solo accompagnatore che non poteva essere un monaco ma un converso e due cavalcature, ad eccezione di Savigny che aveva il diritto a tre cavalcature.»
- «Già nel 116 “l’abate Stefano stabilì di convocare, in un giorno determinato, i pochi abati di Cîteaux, perché, radunati in un sol corpo, dall’incontro e dallo scambio di opinioni di tutti, formassero una sola anima, e, come all’inizio della Chiesa la moltitudine dei credenti era un cuor solo ed un’anima sola, così pure fosse sempre per i monaci cistercensi; e quantunque, poi, si fossero diffusi per tutto il mondo, facilmente, da questo incontro avrebbero potuto ritrovare la possibilità di pacificazione in caso di discordia”.»
- «I monasteri cistercensi, che godevano di larga autonomia di azione, furono in grado di adattarsi alle esigenze ed ai bisogni di vita dei vari paesi e, pur nella solitudine, riuscirono a dare un forte contributo e ad incidere sull’epoca come mai era riuscito a fare il monachesimo prima di allora.»
- «In modo particolare brillava di prestigio l’abate di Clairvaux che, godendo di una rappresentatività schiacciante ed esorbitante nei confronti delle altre filiazioni, si trovò ad esercitare una reale azione di guida per le altre e di controllo nei confronti dell’abate di Cîteaux.»

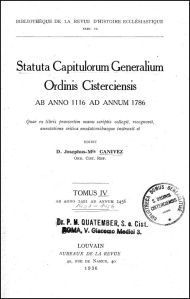
 (la prima parte è
(la prima parte è  Come nella migliore tradizione la vicenda è cominciata con un libro adocchiato su una bancarella. Figuriamoci: Il libro della trappa, di un tale Agustín Roberts1, comprato all’istante, anche con lo stupore che esistesse un libro con un titolo del genere – che infatti si rivelerà essere un «titolo editoriale» di un originale ben diverso, Hacia Cristo. Apertolo all’impiedi davanti alla bancarella medesima, si è presentato con un’avvertenza dal tono e soprattutto dal contenuto assai singolari, che hanno acceso immediatamente il mio interesse. Nella «Nota di edizione» a pagina 9 ho letto infatti che le suore trappiste di Vitorchiano avevano contattato l’editore circa la possibilità di pubblicare in italiano il libretto, assai utile per le postulanti, che loro lo «avrebbero anche semplicemente ciclostilato in un numero limitato di copie»; l’editore aveva letto e valutato, e scoperto che il testo «forse più di ogni altro poteva far conoscere in cosa consiste lo svolgersi quotidiano della vita contemplativa».
Come nella migliore tradizione la vicenda è cominciata con un libro adocchiato su una bancarella. Figuriamoci: Il libro della trappa, di un tale Agustín Roberts1, comprato all’istante, anche con lo stupore che esistesse un libro con un titolo del genere – che infatti si rivelerà essere un «titolo editoriale» di un originale ben diverso, Hacia Cristo. Apertolo all’impiedi davanti alla bancarella medesima, si è presentato con un’avvertenza dal tono e soprattutto dal contenuto assai singolari, che hanno acceso immediatamente il mio interesse. Nella «Nota di edizione» a pagina 9 ho letto infatti che le suore trappiste di Vitorchiano avevano contattato l’editore circa la possibilità di pubblicare in italiano il libretto, assai utile per le postulanti, che loro lo «avrebbero anche semplicemente ciclostilato in un numero limitato di copie»; l’editore aveva letto e valutato, e scoperto che il testo «forse più di ogni altro poteva far conoscere in cosa consiste lo svolgersi quotidiano della vita contemplativa». (la prima parte è
(la prima parte è  Nonostante siano passati quasi cinquant’anni dalla sua pubblicazione, o forse proprio per questo motivo, il libro che Georges Duby ha dedicato all’arte cistercense (e a san Bernardo) si legge con grande piacere, e direi anche con grande profitto1. Il piacere è dovuto in gran parte al testo vero e proprio, steso in uno stile storiografico sempre meno frequentato che non rinuncia, in nome della precisione e del rigore, a un evidente impulso narrativo, sfrondato dagli apparati, che lo rende «appassionante»; mentre il profitto deriva dal fatto che la lettura di Duby del fenomeno artistico cistercense, eminentemente architettonico, potrà anche essere datata e da aggiornare (io però non lo so), ma non può essere di certo del tutto fuori fuoco.
Nonostante siano passati quasi cinquant’anni dalla sua pubblicazione, o forse proprio per questo motivo, il libro che Georges Duby ha dedicato all’arte cistercense (e a san Bernardo) si legge con grande piacere, e direi anche con grande profitto1. Il piacere è dovuto in gran parte al testo vero e proprio, steso in uno stile storiografico sempre meno frequentato che non rinuncia, in nome della precisione e del rigore, a un evidente impulso narrativo, sfrondato dagli apparati, che lo rende «appassionante»; mentre il profitto deriva dal fatto che la lettura di Duby del fenomeno artistico cistercense, eminentemente architettonico, potrà anche essere datata e da aggiornare (io però non lo so), ma non può essere di certo del tutto fuori fuoco.