 Tanto breve il saggio di Renata Rizzo Pavone e Anna Maria Iozzia, Comunità monastiche catanesi tra ’700 e ’800, quanto «gustoso». Letteralmente1. Le due studiose, già direttrici dell’Archivio di Stato di Catania, ed entrambe purtroppo scomparse, hanno infatti spulciato gli Ordinari di alcuni monasteri, in particolare quello benedettino di S. Nicolò l’Arena, con l’intento di ricostruire «il tipo di alimentazione in uso nelle comunità monastiche catanesi nei secoli XVIII e XIX».
Tanto breve il saggio di Renata Rizzo Pavone e Anna Maria Iozzia, Comunità monastiche catanesi tra ’700 e ’800, quanto «gustoso». Letteralmente1. Le due studiose, già direttrici dell’Archivio di Stato di Catania, ed entrambe purtroppo scomparse, hanno infatti spulciato gli Ordinari di alcuni monasteri, in particolare quello benedettino di S. Nicolò l’Arena, con l’intento di ricostruire «il tipo di alimentazione in uso nelle comunità monastiche catanesi nei secoli XVIII e XIX».
Grazie alle serie consistenti e alla ricchezza delle indicazioni riportate circa la qualità dei cibi, la quantità e il numero dei confratelli presenti nel monastero le autrici hanno potuto definire con sorprendente dettaglio i comportamenti alimentari della comunità, a cominciare dai quattro schemi quotidiani prevalenti. Nei giorni «normali» il pranzo prevedeva: carne, minestra, antipasto, arrosto, frutta; la cena: minestra, pesce, «terza cosa», frutta e/o foglia. E già qui cominciano le sorprese, perché la quantità del piatto di carne che apriva il pranzo si aggirava intorno al mezzo chilo a testa, il piatto di pasta che lo seguiva era di circa 150 g, con l’aggiunta di ancora un po’ di carne, mentre l’antipasto, «pietanza abbastanza elaborata da collegare al tornagusto della cucina baronale, era assai vario». A quel «vario» segue un elenco rutilante, dal quale mi limito a segnalare le granatine, «polpette di carne dal volume inusitato», e la impanata «con pasta, lardo, salsiccia e soppressata». In ogni caso dopo c’è l’arrosto, cioè altra salsiccia e alla fine 150 g di frutta. A cena facciamo conoscenza con la «terza cosa» – dopo il primo e 200 g di pesce –, «pietanza molto varia, dolce o salata», ad esempio «ricotta, caciocavallo, pane fritto con uova… cavolo bastardo con alici… caponata con asparagi… sciroppata di mele… pasta siringata, pasta cotta nel mosto…». Il lunedì si riduce un po’ la carne a favore delle uova e nei giorni di astinenza dalla carne largo al pesce! Durante la Quaresima e l’Avvento, in cui la carne scompare quasi del tutto si fa avanti invece una «quarta cosa» (crispelle di riso il lunedì, lenticchie il martedì, pasta fritta il mercoledì…). A pranzo, ad esempio: pesce, minestra, seconda minestra, «quarta cosa», frutta o verdura; mentre a cena: minestra, colazione, sopratavola, là dove la colazione è un piatto di pesce e il sopratavola un po’ di pasta.
«Nei giorni di festa il pranzo si arricchiva in misura proporzionale all’importanza attribuita alla festa stessa», una frase che dà il la a una serie incredibile di prelibatezze e al dilagare dei dolci, serviti nelle grandi occasioni come «quinta cosa» (fagioli, passola [uva senza semi] e castagne), e come «sesta cosa» (gelo di cannella). Tra l’altro nel recepire le novità gastronomiche i benedettini sono sempre all’avanguardia, si nota infatti via via «un’esigenza di maggior ricercatezza ed elaborazione nella preparazione dei cibi, che troverà piena realizzazione agli inizi dell’800», grazie anche all’influenza della cucina francese importata dai cuochi delle famiglie nobili. Ed ecco comparire nei registri «riso in cagnò, barrachiglie di riso e caciocavallo, cutumè di riso o ricotta, sorcicelli di pasta brugnè con caciocavallo e piacentino, gnocchi alla tedesca…» Gli elenchi sono sempre affascinanti e in queste pagine ce ne sono tanti e meravigliosi. (Si vedano i dolci delle monache: «Cannoletti a base di riso, uova e latte, biscotti di mandorle ricoperti di “liffia” (glassa di cioccolata), “mostazzole” [biscotti di sottile sfoglia di farina roccella farciti con mandorle e nocciole abbrustolite, noci, buccia d’arancia legate con vino cotto e miele], cassate di ricotta per Pasqua, “fastucata” [dolce a base di pistacchi legati da zucchero vanigliato e spolverati con cannella], “combaita” e dolce bianco».)
Meno dettagliati i registri degli altri ordini, ma in generale domenicani, carmelitani, minori e minimi paiono un po’ più sobri, sia nella quantità sia nella quantità, ma fino a un certo punto se si considera che «il quantitativo giornaliero di carne pro capite per i carmelitani si aggirava intorno a g. 300 per pietanza e antipasto». I minimi in coda a tutti avevano «un regime alimentare basato essenzialmente su pane, pasta, vegetali e pesce» – pesce di qualità –, ma ogni tanto facevano festa anche loro e «notevolissimo era infine il consumo di “scacciu”, cioè frutta secca, come nocciole, mandorle e noci, che durante la “conversazione” si accompagnava al vino».
E le prescrizioni della Regola? Al capo XXXIX il padre Benedetto dice: «Dunque a tutti i fratelli devono bastare due pietanze cotte e se ci sarà la possibilità di procurarsi della frutta o dei legumi freschi, se ne aggiunga una terza. Quanto al pane penso che basti un chilo abbondante al giorno, sia quando c’è un solo pasto, che quando c’è pranzo e cena. In quest’ultimo caso il cellerario ne metta da parte un terzo per distribuirlo a cena». Ma, per usare le parole di Federico De Roberto, «questa era una delle tante “antichità” – come le chiamava fra’ Carmelo – della Regola. Potevano forse le Loro Paternità mangiare pane duro?»
______
- Il saggio, del 1995, è stato ristampato in Renata Rizzo Pavone e Anna Maria Iozzia, La cucina dei benedettini a Catania, introduzione di G. Giarrizzo, con uno scritto di A. Leonardi, Giuseppe Maimone Editore 2000, pp. 21-53.

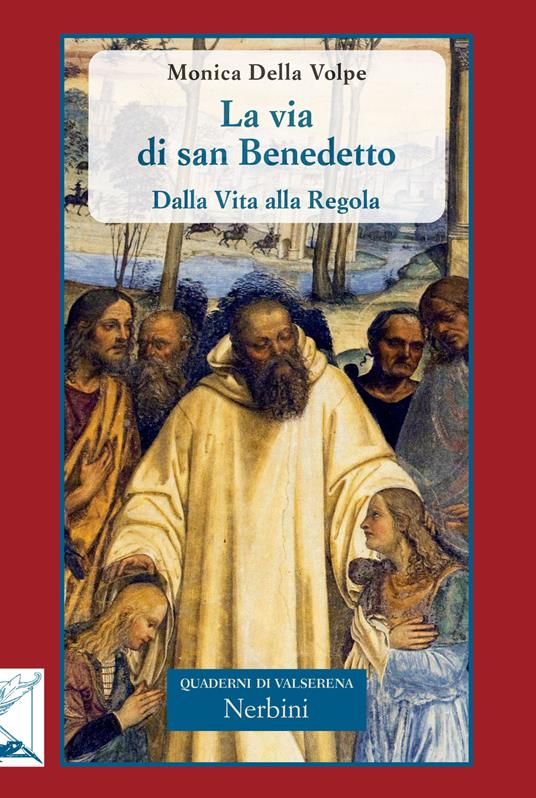 La via di Benedetto di Monica Della Volpe1 è un testo nato da una viva esperienza di lectio all’interno della comunità del monastero trappista di Valserena («Non sono considerazioni astratte: tale è stata la nostra esperienza, riflettendo sulla quale abbiamo raccolto queste considerazioni, e abbiamo meglio capito l’esperienza stessa»), cioè, si potrebbe dire, di «interrogazione» della Regola, letta in parallelo con la Vita di Benedetto di Gregorio Magno, con l’intenzione di evidenziare la diretta dipendenza di quello che, in fondo, è un «testo giuridico» dalla biografia di chi l’ha scritto: «È evidente che san Gregorio ha compreso il valore della via benedettina per l’uomo del suo tempo, e lo ha spiegato, secondo uno stile di racconto sapienziale allora chiarissimo per il cristiano comune, oggi più difficile da interpretare».
La via di Benedetto di Monica Della Volpe1 è un testo nato da una viva esperienza di lectio all’interno della comunità del monastero trappista di Valserena («Non sono considerazioni astratte: tale è stata la nostra esperienza, riflettendo sulla quale abbiamo raccolto queste considerazioni, e abbiamo meglio capito l’esperienza stessa»), cioè, si potrebbe dire, di «interrogazione» della Regola, letta in parallelo con la Vita di Benedetto di Gregorio Magno, con l’intenzione di evidenziare la diretta dipendenza di quello che, in fondo, è un «testo giuridico» dalla biografia di chi l’ha scritto: «È evidente che san Gregorio ha compreso il valore della via benedettina per l’uomo del suo tempo, e lo ha spiegato, secondo uno stile di racconto sapienziale allora chiarissimo per il cristiano comune, oggi più difficile da interpretare».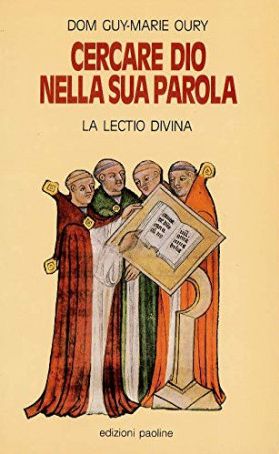 «Ogni relazione con Dio si basa su un diligente ascolto», afferma il benedettino Guy-Marie Oury (1929-2000, professo a Solesmes) nella prima pagina del suo libro sulla lectio divina1, ed è anzitutto nella Sacra Scrittura «che si può incontrare meglio Dio e ciò che egli ha detto di se stesso».
«Ogni relazione con Dio si basa su un diligente ascolto», afferma il benedettino Guy-Marie Oury (1929-2000, professo a Solesmes) nella prima pagina del suo libro sulla lectio divina1, ed è anzitutto nella Sacra Scrittura «che si può incontrare meglio Dio e ciò che egli ha detto di se stesso».

 Sono contento quando iniziative editoriali mi consentono di leggere opere, oggi etichettabili come «oscure», ma che in altri tempi non lo erano affatto, essendo state anzi assai diffuse e molto lette, tanto da conquistare un’altra etichetta, quella ad esempio di «classico della spiritualità medievale». È il caso delle Pie meditazioni sulla conoscenza della condizione umana1, operetta («tractatulus») di ambiente monastico, benedettino, databile tra il 1160 e il 1190. Spesso attribuite in passato a Bernardo di Chiaravalle, le Meditazioni vantano una ricca tradizione manoscritta di circa 250 esemplari (che le presentano da sole o in compagnia di altre opere), cui sono seguite numerose edizioni a stampa, nonché traduzioni in francese, tedesco, italiano, portoghese, fiammingo, ungherese, danese, svedese e islandese. «Oggi, forse, il testo», osserva la curatrice Milvia Fioroni (si noti quel «forse»), «non è più al centro delle pubblicazioni, ma questo tipo di letteratura si trasferisce dal campo della spiritualità a quello della ricerca storica.» Be’, forse, non è esattamente così, o meglio, è senz’altro così, ma non solo.
Sono contento quando iniziative editoriali mi consentono di leggere opere, oggi etichettabili come «oscure», ma che in altri tempi non lo erano affatto, essendo state anzi assai diffuse e molto lette, tanto da conquistare un’altra etichetta, quella ad esempio di «classico della spiritualità medievale». È il caso delle Pie meditazioni sulla conoscenza della condizione umana1, operetta («tractatulus») di ambiente monastico, benedettino, databile tra il 1160 e il 1190. Spesso attribuite in passato a Bernardo di Chiaravalle, le Meditazioni vantano una ricca tradizione manoscritta di circa 250 esemplari (che le presentano da sole o in compagnia di altre opere), cui sono seguite numerose edizioni a stampa, nonché traduzioni in francese, tedesco, italiano, portoghese, fiammingo, ungherese, danese, svedese e islandese. «Oggi, forse, il testo», osserva la curatrice Milvia Fioroni (si noti quel «forse»), «non è più al centro delle pubblicazioni, ma questo tipo di letteratura si trasferisce dal campo della spiritualità a quello della ricerca storica.» Be’, forse, non è esattamente così, o meglio, è senz’altro così, ma non solo. A un primo livello la lettura dello splendido volume dedicato a Margherita Marchi1, la «madre fondatrice» della comunità di benedettine che nel maggio del 1941 prese infine dimora stabile nell’abbazia di Viboldone, nei pressi di San Giuliano Milanese, è un’immersione nella proverbiale «miniera di informazioni»: sulla vita e sulla formazione di m. Marchi, sull’imponente fondo epistolare della medesima, sulle vicissitudini della comunità, dei suoi rapporti con la Chiesa e della sua posizione nel contesto generale, sulle figure di ecclesiastici che la avvicinarono, la accompagnarono, la sostennero, sulla composizione della comunità originaria. Va da sé che ne ricorderò assai poche, di tali informazioni, ma la traccia, per così dire, è lasciata, con forza, stile e qualità, e si potrà sempre tornare al volume, che per fortuna esiste, per verifiche e ripassi molto più agevolmente che tramite ricerche d’archivio.
A un primo livello la lettura dello splendido volume dedicato a Margherita Marchi1, la «madre fondatrice» della comunità di benedettine che nel maggio del 1941 prese infine dimora stabile nell’abbazia di Viboldone, nei pressi di San Giuliano Milanese, è un’immersione nella proverbiale «miniera di informazioni»: sulla vita e sulla formazione di m. Marchi, sull’imponente fondo epistolare della medesima, sulle vicissitudini della comunità, dei suoi rapporti con la Chiesa e della sua posizione nel contesto generale, sulle figure di ecclesiastici che la avvicinarono, la accompagnarono, la sostennero, sulla composizione della comunità originaria. Va da sé che ne ricorderò assai poche, di tali informazioni, ma la traccia, per così dire, è lasciata, con forza, stile e qualità, e si potrà sempre tornare al volume, che per fortuna esiste, per verifiche e ripassi molto più agevolmente che tramite ricerche d’archivio.
